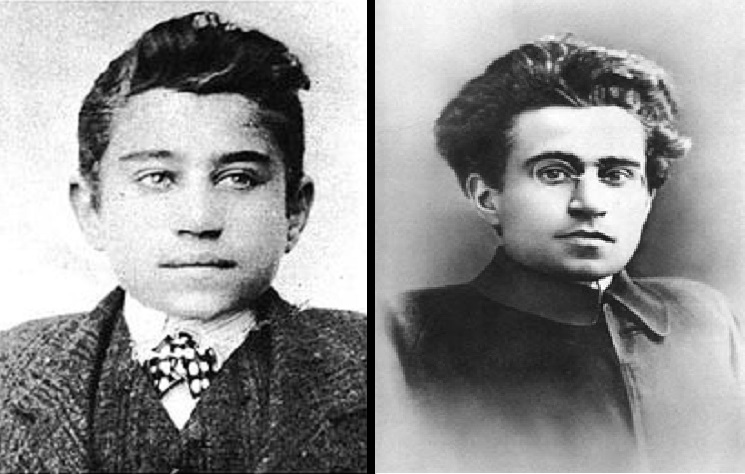Autore originale del testo: Alfredo Morganti
Una storia personale (ma che appartiene a tanti comunisti come me e, credo, anche a tanti italiani non-comunisti).
Mi iscrissi al PCI, di fatto, sin dalla nascita. Poco importa che la prima tessera alla FGCI sia arrivata solo nel 1975 a Villa Gordiani, quando ero ormai un ragazzo. Ma nella mia famiglia comunisti si nasceva, e si nasceva anche cattolici, ma sul serio: rosario nei momenti topici, novene di Natale, messa la domenica, oratorio, processioni in borgata nel mese di Maria (con addobbi, coperte stese come arazzi e altarini improvvisati) nonché, ovviamente, chierichetti da bambini. Mio nonno paterno aveva fatto il seminario ma era comunista sino al midollo. La sorella era perpetua (ma lei votava democristiano). Eravamo una famiglia di contadini romagnoli trapiantata a Roma, divenuta poi di operai tessili o edili (mio padre e mia madre si sono conosciuti in fabbrica). Cattocomunisti purosangue col mito di Giovanni XXIII e di Togliatti.
Tutto questo per dire che il PCI non era una cosa esterna, un partito leggero che si frequentava il martedì dalle 18 alle 20, come se fosse un ufficio. No, il PCI era sullo stato di famiglia, e lo era in modo particolare come pedagogo, compagno, amico, comunità, come una presenza rassicurante, come l’occasione di cambiare il mondo. Ricordo come da piccolissimo mi sedevo al tavolo e ascoltavo i “discorsi” di mio nonno, di mio padre, degli altri amici e compagni. Un nostro cugino di Primavalle conosceva il russo e leggeva la Pravda! Era l’intellettuale della famiglia. L’Unità, ovviamente, c’era sempre e la sera era stropicciata per quante volte era stata sfogliata un po’ da tutti (l’Unità e Grand Hotel, aggiungo, erano l’informazione fissa). Mia madre e mia zia erano allora molto giovani (vivevamo tutti assieme in stile patriarcale in una casa che ospitava 8 persone) e leggevano anche i fotoromanzi. C’era solo un canale tv, poi due, e questa era l’occasione serale per stare assieme col film il lunedì e il quiz il giovedi. Anche perché la borgata degli anni sessanta e settanta di sera era buia, le strade erano fangose e le case sparse. La famiglia, spesso grande, era davvero un bene-rifugio.
Il PCI ha scandito la mia formazione con una declinazione molto berlingueriana, molto unità popolare, molto aperta al diaologo con le altre culture. Io certo ero avvantaggiato dal cattocomunismo delle origini, ma per noi il comunismo erano gli ultimi, i penultimi, gli umili, i più fragili, gli sfruttati, i subordinati che si ergevano e prendevano voce per cambiare in meglio la società e lo Stato. In modo coerente sia con le idee comuniste sia con quelle cattoliche, avviluppate come rami di un ulivo. Il PCI era una forza severa, combattiva, giusta che stava al tuo fianco e non ti faceva mai sentire solo, era una forza popolare, era una forza democratica e si conficcava dentro le cose con la prassi quotidiana, la lunga marcia nelle istituzioni, e non peccava di astrattezza, non era teoria ma corpo a corpo continuo con la realtà. Semmai lo erano un po’ astratti quelli che io chiamavo “gruppettari”, che ci accusavano di revisionismo, di tradimento, di cedimento al nemico, ma che per me non avevano capito nulla di cosa fosse davvero il comunismo. E cioè una forza critica che sta dentro le cose per cambiarle, non se ne discosta, non le disprezza. Ma queste oggi sono sfumature.
Ricordo una cosa, che seconde me è decisiva. In borgata c’erano italiani di ogni provenienza geografica, immigrati come lo eravamo noi dalla Romagna. E in sezione le sfumature di questo popolo erano palesi. Calabresi, marchigiani, ciociari intervenivano al Direttivo con un linguaggio spesso elementare, spesso dialettale, con concetti semplici ma con acume, con intelligenza, e tutti stavamo ad ascoltare anche se qualche loro parola si perdeva per ragioni linguistiche. I miei amici “gruppettari”, intenti ai loro gruppi di lavoro su Marx, si sarebbero alzati dalle sedie, sostenendo che il livello era troppo basso per fare la rivoluzione. E invece no, il livello era altissimo, e dentro la sezione (ma anche fuori di essa) spesso si concretizzava un rapporto diretto, ma politico, con i più umili di noi, con chi abitava la società ai margini, operai, artigiani, anziani pensionati, borgatari. I più giovani come me imparavano a quella scuola l’umanità vera, non le chiacchiere. E la cosa bella, meravigliosa anzi, era l’attenzione con cui il “compagno della federazione”, talvolta della direzione, ascoltava quei discorsi, la cura con cui annotava i concetti. Ricordava i nomi e rispondeva a tutti con serietà, rispetto, meticolosità. Dirigenti che erano spesso professori di filosofia universitari che venivano in borgata, ma non a pagare pegno, semmai a imparare qualcosa che nessun libro, nessuna aula, nessun laboratorio, nessun salotto poteva insegnare. Gli davamo del tu, come si dava ai compagni, ed erano quelli che firmavano in terza pagina articoli ponderosi in cui davano sfoggio di acume e di studio approfondito. Era così.
La fine del PCI, per un comunista, sarebbe come se finisse la Chiesa per un cattolico, se divenisse una struttura leggera, che fa le primarie per eleggere il Papa col maggioritario e chiude l’Osservatore Romano o l’Avvenire, per aprire un profilo social. Ecco. Questo è stato l’impatto per tutti noi quando la falce e martello è stata ammainata. Un fatto politico ma anche sentimentale, emotivo, affettivo. Chiudeva una comunità, non solo un partito. E lo si faceva in un modo che grida vendetta ancor oggi, con uno strappo senza riguardi. Si trattò il PCI come se fosse il PCUS, quando era il Labour italiano, la SPD di casa nostra. Perché il dibattito venne solo dopo, prima si sfregiò una storia. Certo, si elaborò il lutto, si discusse, si cercò di capire il senso di quella svolta, ma l’effetto fu una valanga che portò via tutto o quasi. Io commisi l’errore di aderire alla piattaforma occhettiana. Di votare Sì al congresso. Ancora me ne pento. Perché era più giusto cambiare progressivamente quel partito, piuttosto che dilaniarlo dall’oggi al domani. O forse si tratta soltanto della tarda convinzione di chi oggi capisce quanto manchi a questo Paese un grande partito della sinistra, aperto, largo, plurale, democratico, con lo scopo di cambiare le cose e rimettere in testa a tutto gli ultimi. Gli ultimi, così che divengano primi sin d’ora, o che almeno ci provino a farlo, senza attendere vite migliori e mondi migliori. Senza attendere che il bene trionfi sul male in via definitiva (se mai sarà).
Ecco se riuscissimo a ricostruire lo spirito almeno di quel partito, invece di spezzettarci all’infinito o regalare quel che resta (poco) di una tradizione all’avventuriero di turno, sarebbe già un buon risultato. Ai giovani che non hanno conosciuto o vissuto il PCI dico: non sapete che cosa vi siete persi. Davvero. Lo dico senza inutile nostalgia, ma anche senza il disincanto tanto al chilo che oggi si smercia ovunque si faccia politica. Per questo, a cent’anni dal 1921, dico ancora: evviva il Partito Comunista Italiano, evviva quella storia, evviva quella comunità di donne e uomini semplici ma tosti, evviva chi diceva dopo una riunione: “Al lavoro e alla lotta” (quando quasi lo urlò Pietro Ingrao a una festa dell’Unità in borgata sbottai in lacrime). Ed evviva Enrico Berlinguer, che ha incarnato l’anima più bella e più popolare di quella storia che resta, per me, infinita.
PS, scusate la prolissità, ma sono cent’anni di storia, è il PCI, è la vicenda di milioni di persone e di un Paese che usciva dalla dittatura, dalla guerra e dalla povertà. Glielo dovevo, anche per ricordare mio nonno Peppe e mio padre Franco. Che spero riposino in pace e un po’ di giustizia, quella vera, l’abbiano almeno conosciuta dopo.