Fonte: Limes
PERCHÉ GLI STATI UNITI DEMONIZZANO PUTIN
A Washington domina la rappresentazione della Russia come anti-America e del suo capo quale irredimibile nemico. Mosca deve cedere il suo impero e avviarsi verso la democrazia se vuole essere considerata un partner dal Numero Uno. Il caso Kissinger.
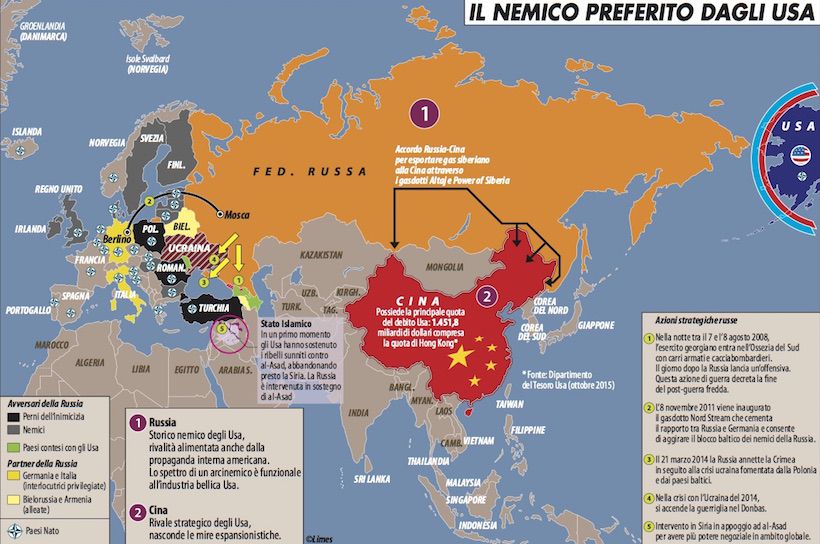
1. «La demonizzazione di Putin non è una politica; è un alibi per non averne una». Era il marzo 2014. La Russia aveva appena scippato la Crimea e si apprestava ad appoggiare i ribelli del Donbas. A pronunciare tale sentenza non era un ingenuo, un pacifista o un propagandista al soldo del Cremlino. Era uno che i russi li aveva combattuti per una vita: Henry Kissinger.
Sulle colonne del Washington Post, l’ex segretario di Stato americano stava illustrando la sua proposta per tamponare sul nascere la crisi in Ucraina tra Russia e Occidente: «Un ponte fra di essi», invece che «l’avamposto dell’uno contro l’altro». Eppure, constatava con allarme, il dibattito pubblico negli Stati Uniti era «tutto per lo scontro» con Mosca. «Ma sappiamo dove stiamo andando?», ammoniva; certo che la risposta fosse no, profetava: «Trattare l’Ucraina come parte di un confronto Est-Ovest farà affondare per decenni ogni prospettiva di portare la Russia e l’Occidente – specialmente la Russia e l’Europa – in un sistema cooperativo internazionale» 1.
Otto anni dopo, quanto è valida la massima di Kissinger? Demonizzare il capo del Cremlino è ancora il surrogato di una politica? Chiederselo oggi sembra quasi un esercizio di stile. E pure in malafede, visto che Putin sta facendo di tutto per demonizzare sé stesso e il suo paese, come testimoniano gli orrori commessi dai suoi soldati.
La domanda però ha senso. Se per Biden il leader russo è un «assassino», un «macellaio», un «criminale di guerra», un «genocida» e «non può restare al potere», gli Stati Uniti desiderano il cambio di regime? La caduta del tiranno come soluzione di tutti i mali? Le precisazioni dell’amministrazione americana, invece di chiarire, complicano il quadro: il presidente Biden ha espresso un desiderio personale, «ha fatto un punto morale». Una gentilezza per dire una gaffe? Certo che no. Sul palco di Varsavia, prima di auspicarne la rimozione, Biden aveva declamato: «È Putin, è Vladimir Putin il colpevole, punto» 2. Può un presidente degli Stati Uniti esprimere un’opinione personale senza fare politica? Difficile. Soprattutto dal momento che il governo di Washington è stato assai meno chiaro dell’aggressore russo nello spiegare che cosa si aspetta da questa guerra. La formuletta «Ucraina indipendente, Russia indebolita e isolata, Occidente più unito» 3 è sufficientemente ambigua da lasciare aperte tutte le strade o quasi.
Vista questa personificazione del fattore scatenante del conflitto, indagare la rappresentazione geopolitica di Putin in America aiuta a interrogarsi sugli obiettivi degli Stati Uniti, su che cosa vogliono dalla Russia e nella guerra d’Ucraina.
2. Putin impersona tutto ciò che la netta maggioranza degli americani rifiuta della Russia. È autoritario, militarista, guida un regime spionistico. È revisionista e lo rivendica apertamente, privo dello stile felpato e schivo dei cinesi. Cerca spazio con la forza in Europa, il continente più importante per gli Stati Uniti. Soprattutto, esige di essere rispettato in quanto capo della Russia, ma la definizione di quel rispetto è agli antipodi rispetto a quella di Washington.
Putin pretende il riconoscimento di alcuni interessi senza precondizioni, in virtù del rango di Mosca: una sfera d’influenza, la subordinazione di altri popoli, un concerto fra potenze, il diritto a co-scrivere le regole del suo funzionamento. Si comporta così perché sente di incarnare una certa idea della Russia. Una nazione imperiale, con una storia gloriosa, abituata a comandare su altri popoli, a cui riconosce dignità inferiore – vedi con quanto disprezzo e con quanta acribia nega che l’Ucraina abbia una propria soggettività 4.
Per gli Stati Uniti, invece, quel rispetto Putin se lo deve guadagnare. Non solo lui: nei trent’anni dalla caduta dell’Urss, Washington non ha mai ritenuto Mosca abbastanza potente da considerare i suoi interessi dalla sua prospettiva. Incapace, testate nucleari a parte, di spaventare come un tempo. In declino irreversibile, testimoniato dal rovescio strategico di aver perso l’Ucraina. La Russia è sempre stata trattata come il soggetto che doveva dimostrare un cambiamento, riforme alla mano, per essere degna di venire accolta nel sistema a guida americana.
L’orizzonte statunitense è sempre stato quello della democratizzazione. Risuona ancora la promessa di Clinton a El’cin nel 1993 a Vancouver: «Signor presidente, la nostra nazione non resterà in disparte quando si tratterà di Russia e democrazia» 5. È il parametro su cui sarebbe stato valutato anche Putin: «Potrebbe diventare molle sulla democrazia (squishy on democracy)», confidò lo stesso Clinton al premier britannico Blair nel 2000 6. Dagli anni Novanta, gli Stati Uniti hanno attivamente promosso il liberalismo politico-economico in Russia: i tecnici di Banca mondiale e Fondo monetario internazionale scrivevano le riforme per i ministeri moscoviti; l’Agenzia per lo sviluppo internazionale ne proponeva di politiche e istituzionali; le fondazioni dei Partiti democratico e repubblicano incoraggiavano le opposizioni; su un versante più duro, i diritti umani entravano spesso come condizione per altre forme di cooperazione (nucleare, clausola commerciale della nazione più favorita) e, quando violati, scattavano sanzioni (legge Magnitskij) 7. Persino l’allargamento della Nato veniva usato come mezzo per promuovere nei nuovi satelliti in Europa orientale regimi conformi e assimilabili. Uno spazio che Mosca avrebbe potuto cogestire il giorno in cui avesse passato il test di occidentalità.
3. Qui arriviamo al cuore della questione. Che cosa implicano la democrazia e l’occidentalità? La fine dell’impero russo e la rinuncia all’eccezionalismo, plasticamente incarnati da Putin.
Per capirlo, rivolgiamoci a una fonte che americana non è ma che agli americani si rivolge. «C’è qualcosa nella loro cultura odierna che rende la maggior parte dei russi, anche dei più istruiti, incapace di semplici manifestazioni di solidarietà umana», scrive su Time lo storico ucraino Jaroslav Hrytsak, lamentando gli scarsi messaggi di vicinanza dai suoi colleghi russi. «Molte delle migliori menti di Russia sembrano soffrire di un complesso ucraino» e prosegue citando i versi con cui Iosif Brodskij prendeva con signorilità la dichiarazione d’indipendenza di Kiev nel 1991, immaginando ucraini sul letto di morte mormorare i poemi di Puškin, non «le flatulenze di Taras» Ševšenko.
«Al cuore di questo atteggiamento verso gli ucraini», sentenzia lo studioso originario della regione di Leopoli, «è il senso di quanto è meraviglioso essere russi (…) un paese con una grande missione (…) tutte le cose russe devono essere grandi». Ma «sepolto nel profondo di questa megalomania c’è un complesso di inferiorità (…) il cronico fallimento nel raggiungere e superare l’Occidente spinge molti a concludere che l’Occidente non fa per loro». Di conseguenza, «molti russi sono pronti a patire privazioni o a infliggerne di eguali ai loro vicini, se serve a provare al mondo la grandezza della Russia». Soluzione: se Putin «domanda la denazificazione dell’Ucraina, bene, la Russia dovrà conoscere la derussificazione. Deve cioè abbandonare le sue ambizioni di Grande Russia, per diventare un paese normale. Dovrebbe farlo da sola, ma con il sostegno o persino la supervisione dall’esterno» 8.
Opinione ucraina? Aleggia pure nella mentalità della classe dirigente americana. Nel 1992, uno dei suoi massimi esponenti, Zbigniew Brzezinski, spiegava che «l’essenza» dell’agenda occidentale per il dopo-guerra fredda era «accertarsi che la disintegrazione dell’Unione Sovietica diventi la pacifica e durevole fine dell’impero russo». Mosca si sarebbe potuta accomodare in un concerto di potenze, ma «per diventare un attore simile, la trasformazione della Russia richiede, come nei casi di Germania e Giappone, liberarsi delle sue aspirazioni imperiali». Con due avvertenze: «Un programma di ripresa per l’economia russa che non cerchi al contempo di trasformarla in uno Stato post-imperiale potrebbe dimostrarsi effimero» e allargamento della Nato sì, a patto di non far sentire Mosca circondata da un nuovo cordone sanitario. «Soprattutto, è geopoliticamente essenziale che l’Ucraina abbia successo (…) aumenterà in automatico le possibilità che la Russia si evolva in uno Stato europeo in via di democratizzazione e post-imperiale» 9. La democrazia è il mezzo. La fine dell’impero della Russia il fine.
Lo pensava pure chi predicava di andarci piano con Mosca. È noto che George Kennan, l’architetto del contenimento dell’Urss durante la guerra fredda, considerasse «un tragico errore» espandere la Nato a est. Meno noto è che anche lui aveva come necessario orizzonte mentale la democratizzazione: «La democrazia in Russia è avanzata come nei paesi che ci siamo appena impegnati a proteggere, se non di più» 10, spiegava a chi gli chiedeva perché fosse contrario ad allargare l’alleanza.
Il punto è che esiste un consenso negli Stati Uniti, radicato nei codici interpretativi della loro cultura, secondo cui prima o poi la Russia deve democratizzarsi e diventare post-imperiale. Si dibatte sui mezzi, sulla velocità, su quanto gli americani devono indurre il cambiamento o assistervi da fuori. Nessuno contempla di interagire con Mosca per ciò che è, non per ciò che si vorrebbe che sia. Nessuno cioè contempla altre soluzioni per convivere con un leader come Putin che mantiene viva nella sua gente una certa paranoia e una certa idea dei russi. Qualcuno in realtà c’è, ma avanza alternative improponibili dal punto di vista strategico (cedere l’Ucraina al Cremlino o sciogliere la Nato come vorrebbero i nazionalisti trumpiani non è popolare né compatibile con l’obiettivo di tenere l’Europa). Oppure inutili, come concentrarsi su interessi comuni troppo laschi (terrorismo, cyber, nucleare) perché riguardano i mezzi, non i fini geopolitici.
L’unico dalle idee chiare sarebbe Kissinger, con la sua naturale inclinazione al pareggio, così poco popolare in una nazione i cui sport prevedono solo vittorie o sconfitte. Ma con una Russia non più minaccia primaria non si può pareggiare sempre, pena farsi distrarre in eterno e permettere alla Cina di accumulare forza nell’ombra.
Il vero problema della visione di Kissinger è la nostalgia. È sostanzialmente la stessa che aveva Bush padre: sfruttare la debolezza dell’Unione Sovietica per farne un socio di minoranza dell’impero americano, elevare il sistema della cogestione dell’Europa nella guerra fredda a nuovo ordine mondiale 11. Ma quel progetto si basava sulla sopravvivenza dell’Urss. Il suo collasso sorprese e spaventò pure gli americani. Con una provocazione, si può azzardare che la fine della guerra fredda abbia prodotto il peggior esito vittorioso possibile per l’America dal punto di vista strategico: ha eliminato il partner sovietico, non il rivale russo. In altri termini, la caduta dell’Urss non ha prodotto la disintegrazione della Russia. Né tantomeno della sua idea di nazione imperiale. Dando modo all’analista George Friedman di profetizzare nel 2009: «Visto il semplice fatto che non si è disintegrata, la questione geopolitica della Russia riemergerà», perché «la mera esistenza di una Russia unita pone una seria sfida potenziale all’Europa» 12. E a chi la domina.
4. Fra le fonti della demonizzazione di Putin sta dunque l’incompatibilità fra le mentalità strategiche di russi e americani. Quanto è diffusa nell’odierna classe dirigente? E con quali tonalità?
Il clima a Washington attorno ai rapporti con Mosca è diventato tossico. Putin è associato alla tenuta del fronte domestico. Non dallo scoppio del conflitto ma nemmeno dall’interferenza nelle elezioni presidenziali del 2016. La vera svolta è stata l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Da quell’attentato alle istituzioni, l’inquilino del Cremlino è visto come fomentatore della tempesta interna all’America, delle frange antisistema. Nelle élite minacciate dilaga il conformismo. Criticare l’approccio del governo genera accuse di intendimenti col nemico, provenienti non dalle istituzioni, non c’è bisogno: la disciplina della tecnocrazia washingtoniana è tale per cui la comunità degli esperti si muove in sintonia patriottica.
Così per esempio un appello di due membri dell’Atlantic Council di smettere di toccare Mosca sulla politica interna e sui diritti umani ha provocato una rivolta dentro lo stesso centro, il cui vero bersaglio sono i finanziamenti del magnate Charles Koch, accusato di voler imporre a suon di danari una politica meno interventista per fare un favore a Putin 13. Oppure basta vedere la fatica della Casa Bianca a nominare il coordinatore Russia del Consiglio di sicurezza nazionale. Uno dei papabili, Matthew Rojansky, direttore del Kennan Institute al Wilson Center, è stato oggetto di una campagna denigratoria, con accuse di eccessiva morbidezza o addirittura di ricevere uno stipendio dal Cremlino 14. Alla fine la carica è andata a un oscuro diplomatico di carriera, Eric Green.
Non stupisce che la squadra di Biden che si occupa di Russia sia uscita molto omogenea. Forte è la componente dei diplomatici, tutti o quasi formati negli anni d’oro dell’interventismo di marca clintoniana (neocon e liberali), fortemente convinti dell’America come nazione indispensabile e della necessità di indurre il cambiamento in Russia.
La figura di maggiore spicco in tal senso è Victoria Nuland, numero due del dipartimento di Stato in cui aveva già militato dal 1984 al 2017, fra i protagonisti dell’intervento degli Stati Uniti per cavalcare (non causare) la rivolta di Jevromajdan a Kiev nel 2014. Nota per i suoi coloriti epiteti («Fanculo l’Europa», «Il multilateralismo è l’inferno»), prima di tornare al potere invocava una svolta nell’approccio «fatalista» di Washington a Mosca. Ammettendo un eccesso di ottimismo nell’aspettarsi che il contatto «col mondo libero avrebbe reso la Russia un partner migliore e più democratico», Nuland invocava di ristabilire un argine contro Putin, definito «uomo ancora molto sovietico». Fra le proposte per riportarlo a negoziare, «concentrarsi su quella singola cosa che preoccupa il presidente russo: gli umori interni». Compito: «Reimparare a comunicare direttamente al popolo russo» perché gli americani «non solo hanno dimenticato come si fa ma hanno accettato l’idea di Putin che ogni appello al russo medio costituisce un’interferenza interna» 15.
Su Nuland è evidente l’impronta di Strobe Talbott, segretario di Stato nel 1994-2001 e poi per 15 anni presidente della Brookings Institution. Amico fraterno di Bill Clinton, al governo era noto come The Russia Hand (l’esperto di Russia) e ha presieduto la graduale estensione al mondo intero delle forme dell’egemonia americana; sotto di lui l’approccio a Mosca ha iniziato a indurirsi. Sotto la sua ala sono passati figure chiave dell’amministrazione Biden: oltre a Nuland, il segretario di Stato Antony Blinken, il suo consigliere Derek Chollet, il direttore della Cia William J. Burns. E poi Kurt Campbell e Angela Stout, rispettivamente coordinatori Cina ed Europa del Consiglio di sicurezza nazionale.
Un netto ritorno al passato rispetto ovviamente a Trump ma pure a Obama, che si era circondato di consiglieri giovani ed estranei come lui ai circoli washingtoniani (the blob, nella definizione del suo assistente Ben Rhodes, Trump la virò in the swamp, la palude, ma il concetto era lo stesso). L’anzianità e l’isolamento di Biden, unica figura rimasta a interpretare gli umori popolari più cauti in politica estera, suggeriscono che rispetto al passato, in cui la guerra concentrava il potere nel presidente, oggi viga una sorta di apparatocrazia.
A proposito di umori popolari. Diversi sondaggi suggeriscono che oltre due terzi degli americani vedono la Russia come nemico 16. Continuano a riconoscere in Putin l’alieno che definisce l’identità nazionale. Sanno che sta attaccando, assieme all’Ucraina, il ruolo egemonico dell’America nel mondo. L’eccezionalismo a stelle e strisce resta fenomeno di massa. Solo ridimensionato. Nell’intensità (per ora la popolazione vorrebbe più aiuti per Kiev, senza entrare in guerra) e nei numeri: il restante terzo scarso di cittadini non ritiene il Cremlino un nemico. Non vuol dire che gli sia amico, ma è molta più gente che in altre fasi di acuta ostilità. Riflesso e insieme causa della faglia popolare, anche la classe dirigente repubblicana è spaccata. La componente russofila di marca trumpiana è minoranza destinata a durare. Altrimenti non sarebbero possibili video di personaggi pubblici che inneggiano a Putin come castigatore del Grande Satana, l’America stessa – o, meglio, l’idea di America come impero.
5. Chiarito che per gli americani non c’è soluzione alla questione russa senza la rimozione della sua mentalità imperiale e il ruolo della demonizzazione di Putin sul fronte interno, resta da chiedersi: gli Stati Uniti puntano concretamente a un cambio di regime a Mosca? Non si può rispondere senza capire la posizione di Washington nella guerra d’Ucraina.
Gli americani hanno diversi interessi da difendere in questo conflitto. Il presupposto è che Putin non deve vincere. Se gli fosse concesso cantare vittoria, dunque di mettere in pausa le ostilità, si tornerebbe alla situazione pre-24 febbraio, molto svantaggiosa per l’America perché la metteva davanti alle crepe della sua influenza in Europa. Con due aggravanti: Mosca avrebbe legittimato l’uso della guerra per ridisegnare la revisione del mondo a guida americana. E userebbe quella legittimazione e le posizioni conquistate (in particolare se arrivasse in Transnistria) per avanzare la pressione sulla Nato, allo scopo di dissolverla per negoziare da posizione di forza un nuovo assetto della sicurezza continentale. Inoltre, visto che anche in questo scenario è molto probabile l’esistenza di un’Ucraina indipendente, Kiev non accetterebbe le perdite territoriali e continuerebbe comunque a combattere.
L’America deve poi garantire la compattezza del fronte europeo per conservare la sua sfera d’influenza più preziosa e scaricare sugli alleati buona parte dei costi del contenimento della Russia. Hitlerizzare Putin risponde dunque anche all’esigenza di riportare nei ranghi gli europei più corrivi verso Mosca, in particolare il duo Francia-Germania, da slacciare definitivamente dalla Russia. Tendenza peraltro non iniziata con la guerra: già prima dell’ascesa di Biden gli attuali vertici del governo statunitense chiarivano che la priorità era riportare a bordo i satelliti dirazzanti.
Washington vuole inoltre approfittare del momento per indurre la Cina a ripensare l’asse sino-russo. Finora l’operato statunitense ha favorito l’avvicinarsi delle due potenze. Se non puoi aprire a nessuno dei due, fai sì che uno salti o sia impresentabile. Demonizzare il suo capo serve nella migliore delle ipotesi a spingere Pechino a non correre in aiuto del socio e nella peggiore a renderglielo inservibile con un isolamento a tempo indeterminato attraverso la minaccia di sanzioni secondarie. Il rischio di cementarli ulteriormente esiste e sarebbe probabile se la Russia riuscisse a non finire gambe all’aria.
Infine, Putin non deve vincere ma non può nemmeno perdere malamente. Il vero interesse esistenziale di Washington nella guerra non è in Ucraina, ma nell’Europa americana. Deve impedire al conflitto di allargarsi al territorio della Nato perché in tal caso dovrebbe gettare la maschera: fare la guerra per proteggere i satelliti oppure perdere totalmente credibilità. Le ostilità si espanderebbero se Putin si sentisse sul punto di essere rovesciato. E tutto lascia pensare che, se subisse una sconfitta o addirittura non riuscisse a ottenere una vittoria presentabile all’opinione pubblica, l’inquilino del Cremlino rischierebbe fortemente.
Per questo gli americani finora hanno resistito a dare le armi e le informazioni necessarie a Kiev per riconquistare i territori perduti nel 2014: già i russi sembrano non accontentarsi del Donbas, senza la Crimea Putin è un uomo morto. Quanto alle sanzioni, è improbabile che vengano rimosse senza un completo ritiro dall’Ucraina. Sui desideri di cambio di regime, li si cerca di confinare al futuro. Da Washington spiegano che non si riescono a immaginare distensioni finché Putin resterà al potere, ma che potrebbero volerci anni. Non è un’opzione in agenda, ma la ritengono uno degli scenari. È un crinale davvero sottile, quello su cui cammina l’amministrazione statunitense.
Possiamo così aggiornare la massima di Kissinger. Demonizzare Putin non è una politica di cambio di regime, almeno non nell’immediato; è un alibi per non convivere con l’idea di una Russia imperiale, per rifiutare il revisionismo di Mosca. E per non avere alternativa al prolungamento della guerra d’Ucraina.
Note:
1. H. Kissinger, «Henry Kissinger: To settle the Ukraine crisis, start at the end», The Washington Post, 5/3/2014.
2. «Remarks by President Biden on the United Efforts of the Free World to Support the People of Ukraine», Warsaw, 26/3/2022.
3. Così il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan nell’intervista a Nbc News il 10/4/2022.
4. Cfr. il discorso di Putin del 21/2/2022; V. Putin, «Russi e ucraini sono un popolo solo», limesonline, 29/7/2021.
5. Cit. in «Summit in Vancouver; Excerpts From News Session: Cementing a New Superpower Relationship», The New York Times, 5/4/1993.
6. Cit. in P. Baumgartner, «Bill Clinton In 2000: Putin “Could Get Squishy On Democracy”», Radio Free Europe/Radio Liberty, 8/1/2016.
7. E. Rumer, R. Sokolsky, «Thirty Years of U.S. Policy Towards Russia: Can the Vicious Circle Be Broken?», Carnegie Endowment for International Policy, 20/6/2019.
8. Y. Hrytsak, «Russia’s Problems Go Far Beyond Putin», Time, 5/4/2022.
9. Z. Brzezinski, «The Cold War and Its Aftermath», Foreign Affairs, vol. 71, n. 4, autunno 1992, pp. 48-49.
10. Cit. in T.L. Friedman, «Foreign Affairs; Now a Word From X», The New York Times, 2/5/1998.
11. Cfr. il discorso di George H.W. Bush, «Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit», 11/9/1990.
12. G. Friedman, The Next 100 Years, London 2009, Allison & Busby, pp. 146-147.
13. L’appello è di E. Ashford, M. Burrows, «Focus on interests, not on human rights with Russia», Reality Check, n. 4, Atlantic Council, 5/3/2021; sulla rivolta interna, si veda D. Lippman, «A war over Russia has erupted at the Atlantic Council», Politico, 11/3/2021.
14. N. Bertrand, «Biden won’t bring on board controversial Russia expert», Politico, 19/4/2021.
15. V. Nuland «Pinning Down Putin», Foreign Affairs, luglio-agosto 2020.
16. Si veda per esempio R. Wike et al., «Seven-in-Ten Americans Now See Russia as an Enemy», Pew Research Center, 6/4/2022.








