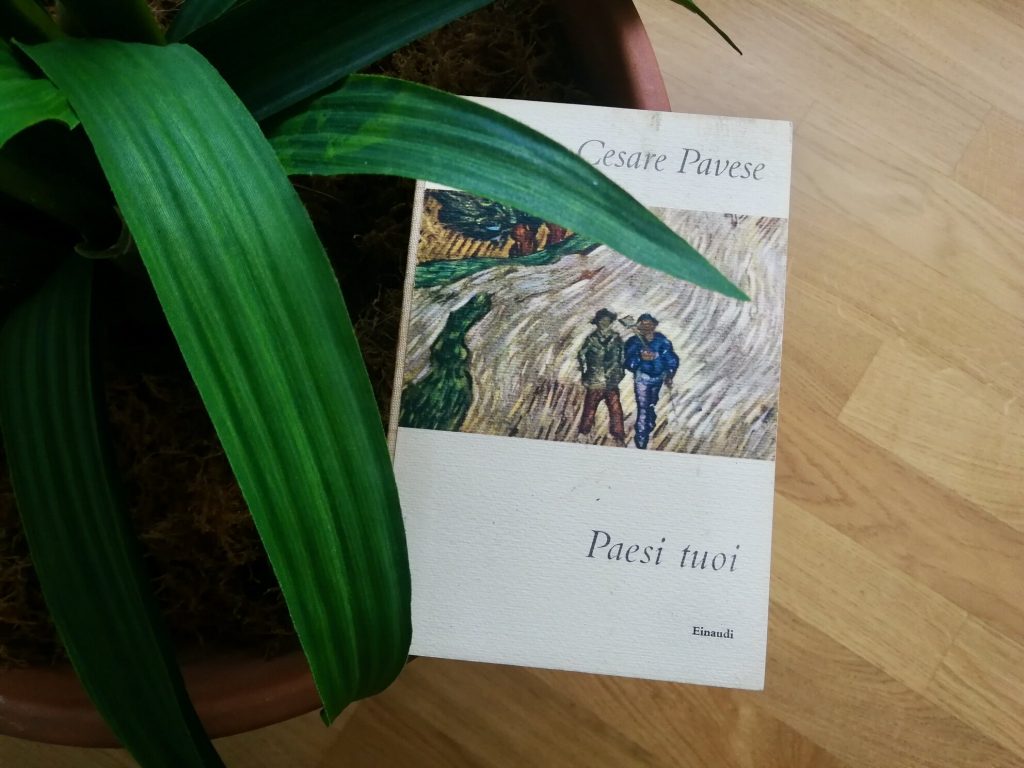“Paesi Tuoi” è il primo romanzo pubblicato (nel 1941) di Cesare Pavese, lo scrittore aveva già scritto e non pubblicato: Il carcere (1939) e probabilmente una prima stesura de La bella estate (1940). Pavese darà fondo per la prima volta al più impellente dei suoi temi narrativi, quello della vita in campagna nelle Langhe e della violenza traumatica e originaria, inventandosi un linguaggio dove il gergo locale trovava, con la mediazione degli scrittori americani che amava e che traduceva, una misura dialogata, diretta, “neorealistica”. Il libro infatti si andrà a collocare in quella che molti chiameranno “corrente neo realista”. A questo proposito Italo Calvino scrisse:
“Il «neorealismo» non fu una scuola. (Cerchiamo di dire le cose con esattezza). Fu un insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, anche – o specialmente – delle Italie fino allora più inedite
per la letteratura. Senza la varietà di Italie sconosciute l’una all’altra – o che si supponevano sconosciute –, senza la varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella lingua letteraria, non ci sarebbe stato «neorealismo». Ma non fu paesano nel senso del verismo regionale ottocentesco. La caratterizzazione locale voleva dare sapore di verità a una rappresentazione in cui doveva riconoscersi tutto il vasto mondo: come la provincia americana in quegli scrittori degli Anni Trenta di cui tanti critici ci rimproveravano d’essere gli allievi diretti o indiretti. Perciò il linguaggio, lo stile, il ritmo avevano tanta importanza per noi, per questo nostro realismo che doveva essere il più possibile distante dal naturalismo. Ci eravamo fatta una linea, ossia una specie di triangolo: I Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire, ognuno sulla base del proprio lessico locale e del proprio paesaggio. (Continuo a parlare al plurale, come se alludessi a un movimento organizzato e cosciente, anche ora che sto spiegando che era proprio il contrario.)…..” (Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno, scritta da Calvino per la sua riedizione nel 1964, quasi venti anni dopo la stesura del romanzo (1947), e contengono un bilancio complessivo dell’autore sull’esperienza letteraria del Neorealismo.)
Paesi Tuoi provoca non pochi attacchi da parte della cultura di regime perchè demistificava quei valori del mondo contadino e della famiglia sbandierati dall’ideologia fascista. Al contrario è esemplare e rappresentativa, la lettera di Vittorio Foa ai genitori, dal carcere di Civitavecchia, 11 agosto 1941
“Ho letto ed ho sentito dire cose entusiastiche sul libro Paesi Tuoi di Pavese. Forse lo leggerò. Leggetelo. Pare che non sia semplicemente un’imitazione di certe mode letterarie americane, ma un’opera originale e profonda sulla vita piemontese, anche se improntata a quei modi espressivi spicci e vigorosi a cui ci hanno ormai abituati Dos Passos e Steinbeck.”
Se Paesi Tuoi è stato collocato come un imprescindibile caposaldo della “corrente neo realista”, nondimeno nel libro “comincia a profilarsi quella poetica del mito che Pavese approfondirà con i suoi studi su Vico e che raggiungerà in seguito soluzioni più mature e consapevoli. Si può cogliere qui, più nettamente che nelle poesie, la contrapposizione, tra città e campagna, che simboleggia fin dall’inizio il dissidio vissuto dallo scrittore, combattuto tra diverse possibilità di appartenenza. Se la campagna rappresenta il mondo felice dell’infanzia, dell’evasione fantastica, del sogno, la città è invece il luogo della responsabilità degli adulti, del lavoro e dell’impegno, ma anche dell’infelicità e dell’angoscia….Solo nelle Langhe, sulle colline, Pavese si illude di trovare una pienezza di identificazione e di vita:..(Mariarosa Masoero e Giuseppe Zaccaria).
Berto (la voce narrante) e Talino, i due protagonisti di Paesi tuoi, si conoscono in carcere, dove occupano la stessa cella: Berto si trova lì per aver investito un ciclista e Talino perché accusato d’incendio doloso ad una cascina nella campagna piemontese, dove vive. Trascorsa la reclusione e scontata la pena, Talino insiste affinché Berto lo segua a Monticello, suo paesino d’origine, per occuparsi della trebbiatrice e delle altre macchine della famiglia in vista dell’imminente mietitura, e guadagnarsi così il pane. Tuttavia, il vero intento di Talino è quello di avere qualcuno che lo possa difendere dalla probabile vendetta del compaesano a cui aveva incendiato la cascina per motivi di gelosia nei confronti della sorella Gisella.
Berto lo segue a malincuore, arriva in campagna e si scontra con un mondo completamente diverso da quello cittadino:
Talino è il personaggio-simbolo “il villano” della campagna primordiale: goffo e scaltro, violento e bugiardo; Berto è il personaggio-esemplare dell’ambiente cittadino: più intelligente di Talino, sa muoversi con tranquillità in città, ma sente la propria vita come inutile, priva di valori: senza scopo e senza amici. Per questo si lascia trascinare da Talino in campagna, alla ricerca di un ambiente e di uomini diversi, di rapporti sinceri, anche se si rende immediatamente conto che è un estraneo a quel mondo contadino.
Il mondo contadino tuttavia non è il mondo felice dell’infanzia, del sogno ma un mondo primitivo, bestiale e di una violenza inaudita: frequentemente Pavese rappresenta i personaggi del romanzo come animali: all’uscita dal carcere di Berto e Talino in modo pacifico: (Talino) “pareva tranquillo e neanche s’accorgeva, che andavamo come i buoi, senza sapere dove…”. Tantissimi sono i riferimenti al mondo animale “…erano giorni che si sfregava contro l’uscio come un gatto”, comincia ad innaffiare da lassù che pareva un cavallo”; “era allegro che sembrava il cane”; “mi guarda con l’occhio del merlo”; “Miliota con la voce da toro che ha lei”; “faceva gli occhi che sembrava un caprone”; “magari con tutte Talino aveva fatto il maiale”. Il gergo usato al culmine della tragedia è mostruoso: (Talino) “aveva fatto due occhi da bestia, dando dietro un salto, gli aveva piantato il tridente nel collo…” e sulla vittima Gisella: “l’ha scannata come un coniglio, peccato era un fisico sano, neanche i maiali resistono tanto…”.
Anche il sesso è brutale e violento: “c’era una collinaccia che sembrava una mammella”: le Langhe rappresentavano il mito del primitivo, legato ai motivi della terra-madre e del sesso. Gisella la sorella sensuale di Talino: “la meno manza delle sorelle” viene paragonata alla frutta. Questo estratto del libro descrive la vita contadina:
“Ero tanto stanco che, dormendo, mi pareva di cadere in un pozzo, e sopra si sporgevano Talino Gisella Pieretto tanta gente; io cadevo, cadevo sempre, mi pareva di cadere tutta la notte. Ero diventato vigliacco come non so cosa, e mentre cadevo allungavo la mano sotto per sentire se c’erano dei rastrelli piantati sul fondo. «Tanto se ci sono t’infilzi » dicevo nel sogno, e sentivo la vertigine e pensavo. Chi sa che rumore faccio quando cado nell’acqua.
Poi mi sveglio e non ero più io. «Anche se ti svegli, – pensavo – devi ancora salire su dal pozzo». Invece trovo tutto quieto e la collina lavata nel sole, e non un’anima in giro. Talino aveva avuto il criterio di andarsene senza svegliarmi. Mentre sonnecchiavo, sentivo qualche movimento nella stalla; poi, il caldo del sole sulle gambe. Allora mi torna in mente Gisella, e mi siedo sul materasso, e riprendo le forze.[…]
A mezzogiorno vengono a chiamarmi e si mangiò un’altra volta il minestrone di verdure, e le acciughe e il formaggio. Era così che quelle donne crescevano spesse, ma Gisella che adesso mi guardava ridendo, sembrava invece fatta di frutta. Perché, una volta finito, chiedo a Talino se non aveva delle mele, e lui mi porta in una stanza dove ce n’era un pavimento, tutte rosse e arrugginite che parevano lei.
Me ne prendo una sana e la mordo: sapeva di brusco, come piacciono a me.
— Sono le mele di Gisella, — fa Talino mentre torniamo a tavola.
— Perché? — chiedo a Gisella. — Covate le mele?
Non capivano mica. Invece il vecchio mi spiega che quando nasce una figlia si pianta un albero perché
cresca con lei.
— Quand’è nato Talino, chi sa cos’avete piantato, — dico. — O legna da bruciare o una zucca.
Salta su il gorba che mi aveva lustrato la macchina e dice: — Perché non si pianta una vigna per figlio?
Così si farebbe piú vino.
— Saremmo i padroni di tutta la collina a quest’ora, dice l’Adele.
Io guardavo Gisella e Miliota. Talino dice: — E per te, macchinista, cos’hanno piantato?
— Grane, — gli faccio, — grane e tabacco, questo sí: ma sui marciapiedi di Torino il tabacco non cresce e allora mi tocca comprarlo. Le grane le trovo per niente….”
L’attrazione di Berto per Gisella avrà un ruolo fondamentale nella tragedia che si andrà a compiere e che conclude il romanzo.
[…] Mi ricordo che Gisella guardava dritto nel grano, mentre bevevo. Guardava tenendomi il secchio a mani giunte, con fatica, come aveva fatto per Ernesto ma lui lo guardava, e con me stava invece come se godesse facendosi baciare. Quando ci penso, mi sembra così. O magari era soltanto lo sforzo, e il capriccio di avercene due intorno che bevevano. Non gliel’ho più potuto chiedere.
Ecco che saltano dal carro Talino e Gallea. Vengono avanti come due ubriachi, Talino il primo, con le paglie in testa e il tridente nel pugno.
Là si lavora e qui si veglia, fa con la voce di suo padre.
C’è chi veglia di notte e chi veglia di giorno, gli risponde Gisella. Ma lui dice: Fa’ bere, e si butta sul secchio e ci ficca la faccia. Gisella glielo strappa indietro e gli grida: No, così sporchi l’acqua. Dietro, vedo la faccia sudata dell’altro. Talino, fa Ernesto, non attaccarti alle donne.
Forse Gisella cedeva; forse in tre potevamo ancora fermarlo; queste cose si pensano dopo. Talino aveva fatto due occhi da bestia e, dando indietro un salto, le aveva piantato il tridente nel collo. Sento un grosso respiro di tutti; Miliota dal cortile che grida “Aspettatemi”; e poi Gisella lascia andare il secchio che m’inonda le scarpe. Credevo fosse il sangue e faccio un salto e anche Talino fa un salto, e sentiamo Gisella che gorgoglia: Madonna! e tossisce e le cade il tridente dal collo.
Mi ricordo che tutto il sudore mi era gelato addosso e che anch’io mi tenevo la mano sul collo, e che Ernesto l’aveva già presa alla vita e Gisella pendeva, tutta sporca di sangue, e Talino era sparito.
Vinverra diceva «d’un cristo, d’un cristo» e corre addosso ai due nel trambusto la lasciano andar giù come un sacco, a testa prima nel fango. – Non è niente, – diceva Vinverra, – è una goffa, àlzati su -. Ma Gisella tossiva e vomitava sangue, e quel fango era nero. Allora la prendiamo, io per le gambe, e la portiamo contro il grano e non potevo guardarle la faccia che pendeva, e la gola saltava perdendo di continuo. Non si vedeva più la ferita.
Poi arrivano le sorelle, arrivano i bambini e la vecchia, e cominciano a gridare, e Vinverra ci dice di stare indietro, di lasciar fare alle donne perché bisogna levarle la camicetta. – Ma qui ci vuole un medico, – dico, – non vedete che soffoca? – Anche Ernesto si mette a gridare e per poco col vecchio non si battono. Finalmente parte Nando e gli grido dietro di far presto, e Nando corre corre come un matto.
– Altro che medico, – dice Gallea che ci guardava dal pilastro – ci vuole il prete.
– E Talino? – fa Ernesto, con gli occhi fuori.
In quel momento l’Adele tornava col catino correndo e si fa largo e s’inginocchia. Mi sporgo anch’io e sento piangere e vedo la vecchia che le tiene la testa, e Miliota che piange e l’Adele le tira uno schiaffo. Gisella era come morta, le avevano strappata la camicetta, le mammelle scoperte, dove non era insanguinata era nuda. Poi la vecchia ci grida di non guardare. Mi sento prendere il braccio. – Dov’è Talino? – chiede ancora Ernesto.
Si fa avanti Gallea. – È scappato sul fienile, – ci dice tutto scuro, – gli ho levata la scala.
Ernesto voleva salire. Gallea lo tiene e lo tengo anch’io. Batto i piedi in un manico. Era il tridente di Gisella, tutto sporco sul manico ma non sulle punte. – Teniamo questo, – gli dico, – senz’un’arma Talino è un vigliacco.
Poi sentiamo di nuovo tossire. Meno male, era viva. Il fango dov’era caduta col secchio faceva spavento, così nero; e la strada fino al grano era sempre più rossa, più fresca. Vinverra ricomincia a bestemmiare coi bambini, e si guardava intorno: cercava Talino. Si alza l’Adele e dice a Pina: – tu va’ avanti -. Poi chiamano Ernesto che venga a aiutare. Io no, perché ero nuovo, e da quel momento mi cessò il sopraffiato e cominciarono a tremarmi i denti. La prendono Ernesto e Vinverra; e Miliota le teneva un braccio. La vecchia mandava via i bambini. Attraversano adagio il cortile, le avevano coperto le mammelle, entrano in cucina. Le vedo l’ultima volta i capelli che pendevano e una gamba scoperta. Poi la portano su.”
La morte di Gisella viene descritta come una sorta di sacrificio rituale. Quando Talino uccide Gisella, l’acqua del secchio portata per dissetare si rovescia e, con il sangue della vittima, impregna la terra. La tragedia si colloca al tempo della mietitura, nella calura dell’estate e nel momento di massima esplosione delle energie vitali della terra.
Chi non si scompone più di tanto, nonostante l’inaudita violenza del figlio, è il patriarca Vinverra, duro come un albero conficcato in collina, che poco dopo la tragedia ordinerà di continuare il lavoro, su quella terra arida che assetata ha bevuto e assorbito in fretta il sangue di Gisella.
Il dramma finale è la metafora dello scontro tra la natura viva, viscerale, della campagna (Tallino)e la natura distaccata, calcolatrice, sorniona della città (Berto).
Il dramma finale di Paesi tuoi è il simbolo della bestialità dell’istinto umano. Il lettore assiste alla tragedia dal punto di vista di Berto, che si sente responsabile per non aver evitato la tragica fine di Gisella, ma al contempo rappresenta, il «modo di pensare» di Pavese che trova nella gelosia solo la miccia per esplodere, ma che in realtà la tragedia ha cause e genesi molto più profonde: la povertà, la condizione misera della vita, l’abbrutimento dell’animo.