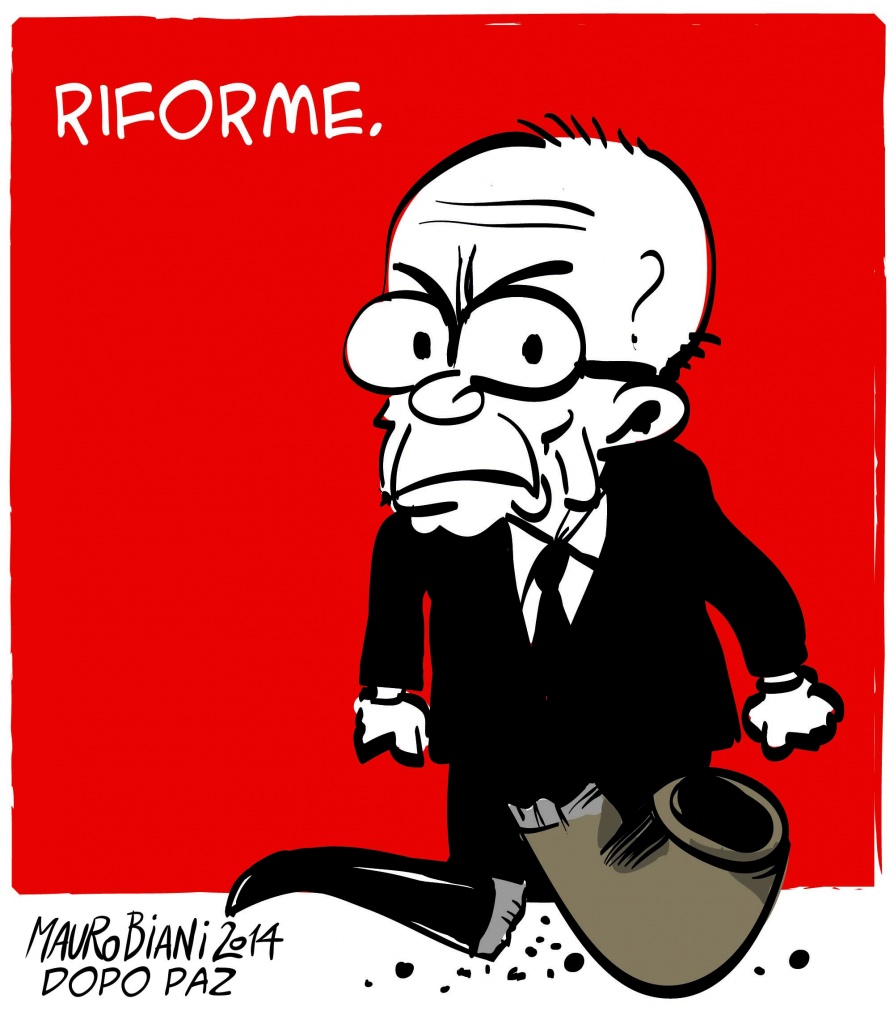Fonte: Il Manifesto
Url fonte: http://fondazionepintor.net/parlamento/azzariti/senato/
di Gaetano Azzariti, 28 ottobre 2014
Il disegno di legge di riforma costituzionale approvato in prima lettura al senato e attualmente in discussione alla camera è assai ampio e articolato. Mi limiterò qui a verificare la coerenza complessiva del modello prescelto, per poi soffermarmi su un unico aspetto specifico, particolarmente qualificante l’ampia revisione proposta.
Per quanto riguarda il modello, la scelta compiuta dal governo — e recepita dal senato — è stata assai impegnativa. Non ci si è limitati infatti a decretare la fine del bicameralismo perfetto e ad escludere dal circuito fiduciario una delle due camere (il senato), prospettiva da tutti condivisa, ma si è adottato la particolare configurazione del «senato delle autonomie», con il contestuale rifiuto di altre ipotesi pur prospettate sia in sede di dibattito pubblico sia in sede propriamente parlamentare.
Scartate le proposte di «senato delle garanzie» (ipotizzato dal senatore Chiti) e quella del «senato delle competenze» (suggerito dalla senatrice Cattaneo), non è stata presa neppure in considerazione la più radicale e limpida soluzione monocamerale. Non discuterò qui la scelta compiuta, vorrei invece soffermarmi su alcune anomalie che sembrano emergere e che rischiano, se non comprese o corrette, di definire un «senato delle autonomie» debole, se non addirittura una sua configurazione «degenerata». E, ci ricorda Aristotele, la «degenerazione» dei modelli è il rischio maggiore di ogni scelta politica.
Come ci insegna il diritto comparato, la scelta del senato delle autonomie è funzionale alla valorizzazione degli enti territoriali — è l’opzione preferita dagli stati federali. L’anomalia della proposta di revisione — la sua debolezza strutturale — è che essa ne prospetta l’adozione nel momento di più profonda crisi del regionalismo non per invertire la rotta, rilanciando il modello autonomisitico, bensì con l’esplicito proposito di assecondare un processo di riduzione dei poteri di questi enti. Il nuovo testo della costituzione, rispetto alla riforma del 2001, ha un’impronta marcatamente statalista, prevedendo una forte ricentralizzazione delle competenze, eliminando la potestà legislativa concorrente, reintroducendo la clausola dell’interesse generale.
La stessa vicenda che ha portato a definire il modello appare sintomatica e dimostra la volontà non di valorizzare, bensì d’emarginare, il ruolo politico e costituzionale delle regioni. La proposta originaria era quella di un «senato dei sindaci» e la stessa relazione del governo al disegno di legge costituzionale, nonché ancora la relazione dell’on. Sisto al testo così come è giunto alla camera, riconoscono che la rappresentanza regionale funge da «contrappeso» al nuovo assetto del riparto delle competenze legislative tra stato e regioni.
È forse a questa debolezza strutturale che devono farsi risalire alcune ambiguità di formulazione inserite nel testo. Non credo sia corretto, in realtà, affermare che il Senato «rappresenta le istituzioni territoriali» (secondo la proposta di modifica dell’articolo 55 Cost.), né che i senatori siano «rappresentativi delle istituzioni territoriali» (secondo la proposta di modifica dell’articolo 57 Cost.).
A rigore, infatti, la rappresentanza istituzionale dovrebbe implicare — così come è in Germania — una scelta dei senatori da parte dei governi locali «che li nominano e li revocano» (art. 51 GG), il voto unitario di tutti i senatori di una stessa regione (ovvero Länder: art. 51 GG), nonché l’obbligo — imposto in Germania per via di prassi — di rispettare le direttive che vengono impartite dai governi locali. Solo in tal modo l’istituzione in quanto tale è rappresentata nell’organo senatoriale.
Nulla di tutto questo è previsto nel disegno di legge costituzionale. Si stabilisce, invece, un’elezione politica di secondo grado da imputarsi ai consigli regionali, elezione che deve avvenire con metodo proporzionale (proposta di modifica dell’articolo 57) al fine di garantire la partecipazione delle opposizioni politiche. Questo meccanismo di scelta dei membri del senato non produce una rappresentanza dell’ente, bensì assicura una rappresentanza del ceto politico locale e dei partiti nazionali nelle loro conformazioni territoriali. Viene inoltre conservato il divieto di mandato imperativo anche per i senatori (proposta di modifica dell’articolo 67). Questi dunque non rappresentano l’ente. In caso, il punto critico è che essi non rappresentano più neppure la Nazione, rischiando di rappresentare solo il ceto politico di appartenenza. Sarebbe opportuno, allora, sciogliere questo nodo, o almeno modificare quanto scritto agli articoli 55 e 57 (nuova versione), indicando — come in altre costituzioni europee — che non di rappresentanza istituzionale si tratta, ma di una mera — e ben più generica — rappresentanza territoriale. Un modello dunque debole di senato delle autonomie.
Tra le misure più incisive inserite nel disegno di legge costituzionale v’è l’introduzione dell’istituto del «voto a data certa» (proposta di modifica dell’ultimo comma, articolo 72).
Ora è evidente — al di là di ogni considerazione di merito o di opportunità — che la possibilità data al governo di imporre al parlamento una delibera entro 60 giorni incide profondamente sugli equilibri costituzionali, rafforzando le prerogative dell’esecutivo. Bene ha detto la presidente della Camera quando ha rilevato che «l’esigenza di disporre di procedure e tempi certi (…) potrà essere soddisfatta pienamente e in modo equilibrato solo qualora non determini uno schiacciamento del ruolo del parlamento, ma ne salvaguardi invece le prerogative». A me sembra che un rischio di «schiacciamento» ci sia, soprattutto vista la troppo generica formulazione adottata.
Escluse alcune ipotesi (leggi bicamerali, elettorali, di ratifica dei trattati internazionali, leggi approvate a maggioranza speciale) il governo può chiedere il voto sul suo testo entro 60 giorni in tutti i casi semplicemente indicando che il disegno di legge è ritenuto «essenziale per l’attuazione» del suo programma. Una formulazione assai generica, che sostanzialmente rimette al governo stesso l’ampiezza del suo potere. Nulla impedirà, infatti, di far ritenere essenziale per l’attuazione del programma ogni disegno di legge, anche il più esoterico.
In fondo, la vicenda dell’abuso della decretazione d’urgenza e l’interpretazione disinvolta dei ben più stringenti limiti della «straordinaria necessità ed urgenza» dovrebbero far capire che non sarà una formula di stile («essenziale per l’attuazione del programma») a frenare l’abuso del nuovo istituto da parte dei prossimi governi. Almeno la commissione istituita dal governo Letta proponeva di limitare nel numero la possibilità di ricorrere a quest’istituto.
Anche la scelta rimessa al governo di stabilire su quale testo votare (su quello «proposto» o su quello «accolto» dal governo) appare pericolosa: si rischia di far venir meno ogni interesse del governo a che sia il parlamento ad approvare — entro i 60 giorni stabiliti — il disegno di legge. Ed anzi può favorire il disinteresse — se non propriamente un’azione di contrasto — del governo e della sua maggioranza, che, impedendo al parlamento di decidere, può assicurare l’approvazione della legge nel testo deciso dal governo.
Dal diritto comparato bisogna imparare anche per gli esempi negativi. E il più vicino parente del voto a data certa è l’istituto francese del vote bloqué. Un istituto che ha concorso a rendere il parlamento d’oltralpe tra i più deboli in Europa e ha contribuito a concentrare l’intera dialettica politica altrove: nel rapporto tra presidente della Repubblica e primo ministro. Se si vuole salvaguardare un ruolo autonomo al parlamento italiano nell’attività di produzione normativa, un argine al potere legislativo del governo dev’essere seriamente posto.
Il testo riprende e sintetizza il contenuto dell’audizione in prima commissione al senato.
da il manifesto del 29 ottobre 2014