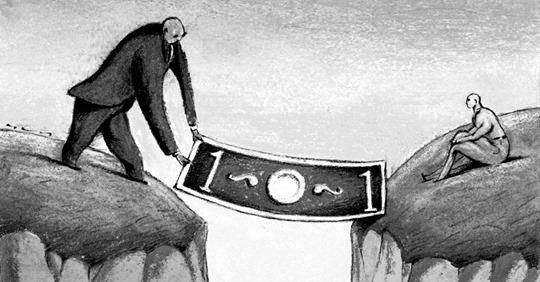1. I limiti al potere economico
Il limite al potere economico in paesi capitalistici liberali
dell’occidente è costituito da un lato dallo Stato e dall’altro dal
conflitto. Senza questi due poli, la logica di un sistema la cui molla
produttiva è nell’accumulazione privata produrrebbe uno squilibrio
sproporzionato, se non unilaterale, di potere e una logica unica di
organizzazione della società.
La Stato va inteso come luogo nel quale ha modo di esprimersi
e affermarsi un punto di vista collettivo, attraverso istituzioni che
fungono da contrappeso a ciò che produrrebbe il mercato lasciato
a sé stesso; nello svolgimento delle loro funzioni ne prevengono e
correggono gli esiti, integrano e proteggono i cittadini, determinano
le regole e ne controllano il rispetto. Il conflitto, è, invece, l’azione
di gruppi sociali fortemente intenzionati a far rispettare la legge ed
estendere i diritti politici, sociali e civili; un’azione, che si esprime
direttamente o trova rappresentanza nelle forme e nelle aggregazioni
della politica. Può contraddire la logica del mercato e opporsi ai
suoi effetti. Entrambi sono espressione e affermazione dei processi
democratici, che integrano un principio di cittadinanza e pari
dignità nell’ordinamento che scaturisce dal mercato.
Non va perso di vista, tuttavia, che, per quanto la fisarmonica
tra potere di mercato e cittadinanza possa aprirsi in direzione di
incorporare un ampio spettro di elementi di democrazia sociale,
l’apertura incontra sempre dei limiti,
perché l’ambito capitalistico in cui avviene
il processo politico ed economico non
ammette soluzioni radicali che arrivino
a contraddire la logica di accumulazione
privata e demotivarla. Quella logica non
consente che lo schiacciamento dei profitti
privati vada oltre certi limiti, e nemmeno
che essi siano valicati dalla redistribuzione del reddito e dall’assetto
ordinamentale e di controllo. Né potrebbe essere sfidato il principio
della proprietà privata oltre confini che diano luogo a reazioni
capaci di rimettere in riga le velleità riformiste. In un certo senso,
la democrazia è a sovranità limitata nell’ambito del capitalismo. Le
armi economiche e politiche e di mobilitazione che hanno gli interessi
economici sfidati – che sono assopite, ma vigili, in un compromesso
sociale accettato – verrebbero attivate nella loro massima potenza di
incisione qualora l’ordine del mercato fosse minacciato in qualche
punto vitale. Non è un caso che sia difficile rintracciare programmi
e perseguimenti radicali in direzione riformista (forse quello più
estremo, a memoria dello scrivente, è il piano Meidner in Svezia e la
riforma dei suoli urbani in Italia, entrambi regrediti o abbandonati),
ma è indubbio che per lunghi anni nel dopoguerra, in occidente, il
capitalismo sia stato disciplinato, che principi di cittadinanza e di
diritti sociali siano avanzati progressivamente e il punto di vista
dei gruppi sociali organizzati abbia avuto potere di incidenza. Ci
si è riferiti spesso per delineare questo quadro al ‘compromesso
socialdemocratico’.
Ciò che la storia degli ultimi decenni racconta, che seguiremo
in queste note, è una storia di affievolimento di quei contrappesi.
Racconta, ed è sviluppo più recente, la forma distorta in cui essi
tendono a ricrearsi.
In un certo senso,
la democrazia è a sovranità limitata n e l l ’ a m b i t o d e l capitalismo
Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico
2. Il mutamento dei rapporti di forza tra potere politico ed
economico
Nella retrocessione del potere politico di fronte a quello
economico negli ultimi trent’anni (ma forse ormai quaranta) è
indubbio che un posto di rilievo lo occupi l’indebolimento degli
strumenti stessi della politica avvenuto con l’evoluzione della
società capitalistica verso un ambito globale di operazione, privo di
rilevanti barriere e dominato dalla pervasività della finanza. È noto
che la dimensione planetaria dei problemi e dell’orizzonte di azione
degli attori economici minino l’azione dello Stato nazionale. Ma ciò
che ha prodotto questo esito non è tanto (e non solo) la crescita di
giganti economici che operano come potentati su uno scacchiere
mondiale e gestiscono le proprie strategie più o meno incontrastati,
impattando e condizionando (con le loro decisioni e capacità
di imporre le loro ragioni) il potere degli Stati. È soprattutto un
meccanismo indiretto, più complesso da dipanare analiticamente,
che ha operato attraverso fattori costrittivi che hanno stretto le
politiche in una morsa e le hanno tenute in binari circoscritti,
spianando la via all’affermazione del potere economico e creando
meccanismi per cui quest’ultimo ha avuto agio di rafforzarsi su sé
stesso.
Le promesse nate negli anni ’70 per chi (a livello di
responsabilità politica) ne avesse seguito i dettati di liberalizzazione e
privatizzazione delle economie prefiguravano una grande cavalcata
produttiva (che avrebbe dovuto gettarsi alle spalle l’impasse di quel
decennio) attraverso la liberazione dalla ‘inevitabile inefficienza
dello Stato e della penalizzante regolazione’, dalla ‘inutilità (e
danni inflazionistici) arrecati dalle politiche della domanda’,
dalla ‘distorsione nel mercato del lavoro portata dai sindacati’,
dalla ‘perdita di opportunità che comporta il controllo pubblico
delle imprese’, dalle ‘controindicazioni del welfare state sul piano
dell’efficienza e della tassazione’; tutte idee che si diffondono in
quegli anni e presuppongono un affidamento al mercato. Idee che
affermano la competizione in campo aperto e l’urgenza di vincere
la sfida della competitività e che, nella misura in cui trovano
rispondenza nell’azione dei singoli Stati, creano la gabbia di acciaio
che si stringe a poco a poco attorno alle politiche (economiche e non
solo), sempre più pressate dalla loro stessa interazione a spingersi
verso indirizzi considerati il viatico per la crescita, di cui divengono
prigioniere. Adottandoli, trasmettono la stessa pressione all’esterno
fino a far divenire il regime che ne scaturisce una vera e propria
regolazione mondiale, una regolazione sempre più compulsiva e a
maglie strette.
L’imperativo alla competitività, al progresso tecnico e a
garantire le molle dell’accumulazione dà ora, nella competizione
globale, una forza irrobustita al potere economico per dettare
l’agenda della politica economica (e, per derivazione, della politica
tout court); forza che usa verso tutto ciò che è percepito come ostacolo
alla competitività (politiche redistributive, tassazione, protezione
del lavoro, vincoli normativi, spezzoni residui di protezionismo).
L’azione pubblica – ai nuovi rapporti di forza e alle nuove costrizioni
esterne (da cui non ha potuto o saputo sottrarsi) – è spinta quindi
a prendere in considerazione solo direzioni che assecondino le
richieste di libertà del capitale privato dall’interferenza con altre
logiche, o, come si dice, creando condizioni business friendly. Il
rischio di non conformarsi alle attese del nuovo consensus è di
perdere la base produttiva, e, ancora: trovarsi con la finanza che
volta le spalle al paese.
3. Lo sfondo culturale
Un risvolto culturale si accompagna a questo rovesciamento
dei rapporti di forza per fornire quelle mediazioni che lavorano alla
accettazione e legittimazione di un sistema che persegua la via della
‘modernizzazione’. Non solo accompagna quella strutturazione dei
rapporti di forza, ma la cementa. Il punto è che l’ineguaglianza di
risorse politiche, di potere, di influenza e di status, che è prodotta
dai meccanismi che si instaurano, dà l’opportunità alle classi
economicamente beneficiate o dominanti (e politicamente influenti)
di trasmettere la propria visione del mondo e farla divenire
egemone. È parte del processo il peso squilibrato nel possesso di
strumenti per il controllo dei centri che trasmettono informazione e
producono il ‘senso comune’, le idee, i valori, la visione della realtà
e i modi di pensare.
In primo luogo, trasmettono la naturalità e assenza di
alternative dei processi in atto, e il senso di impossibilità di deviare
Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico
dalle opzioni ritenute percorribili in economia. Grazie alla disparità
di mezzi politici le élite economiche e sociali e il vertice del settore
produttivo hanno potuto pesare abnormemente nelle decisioni
collettive e nella rappresentanza sociale, e farsi proteggere dal
potere politico. La società occidentale è diventata, in definitiva,
più oligarchica ed elitaria di quanto fosse mai stata e priva di
rilevanti contrappesi rispetto al dominio delle logiche economiche
privatistiche.
4. Non tutto è lineare, ma finisce per esserlo
Beninteso, sarebbe sbagliato vedere il tutto sotto l’ottica di un
‘piano del capitale’, né è corretta una personificazione come corpo
unico degli attori che agiscono nei mercati finanziari (e no). Non è in
discussione, ovviamente, che vi sia una capacità di azione e di dettare
l’agenda in capo alle multinazionali, ma i protagonisti sono attori
dispersi mossi da proprie logiche (di accrescimento di profitto, di
conseguimento di capital gains, di protezione dei valori patrimoniali,
di conseguimento del massimo rendimento, di preservazione di un
ambito politico-sociale in cui tutto questo sia possibile). Malgrado
questa dispersione, è anche vero che, agendo dentro quelle logiche,
è come se i mercati votassero, promuovendo o bocciando le politiche
dei governi (con conseguenze virtuose o deleterie su variabili
chiave, quali il tasso di cambio, di interesse, il finanziamento del
debito, l’andamento di borsa, le condizioni di finanziamento
dell’economia, le riserve valutarie ecc.). Implicitamente influiscono
sulla scelta dell’assetto economico al posto dei cittadini. Quei
governi che provassero a prendere
decisioni contrarie a quel consensus
le vedrebbero poi neutralizzate da
reazioni avverse nel mercato e si
troverebbero costretti a correre ai
ripari in una rapida marcia indietro.
Sarebbe altrettanto forzato
identificare – nella genesi dello
squilibrio nei rapporti di forza – i governi (occidentali) con gli
interessi dello strato privilegiato della popolazione o dal potere
economico, né è immancabilmente vero che la loro azione sia stata
I governi che provassero a
prendere decisioni contrarie
al consensus le vedrebbero
poi neutralizzate da reazioni
avverse nel mercato
sempre allineata ai canoni del consensus. I governi rispondono a
un elettorato variegato, sono frutto di coalizioni composite e non
sono mai tutt’uno con la borghesia più abbiente, il grande capitale
e le élite professionali, né necessariamente sono i loro fiduciari.
L’allineamento può non essere completo, né l’operare del mercato
essere necessariamente senza regole, né la forza della costrizione
competitiva essere assoluta. Eppure, la pressione esercitata da un
processo che spinge a uniformare la società ai dettati del mercato e
della competizione globale crea una pratica nella conduzione degli
affari che non si discosta se non per varianti modeste da un canone
standard, perché il comportamento dei governi è divenuto impotente
di fronte al succedersi degli eventi, perché ha internalizzato quei
canoni come via di uscita da qualsiasi difficoltà e perché lo stesso
comportamento è tenuto dentro binari stretti da logiche ‘coercitive
esterne’, che possono essere rotte solo con una forza politica
straordinaria, mentre questa si arrende progressivamente ai vincoli
che trova. In nome di quei vincoli le correnti politiche e di opinione
(o gli interessi) che producono quel consenso possono mantenere
la pressione sulle decisioni e chiedere con fermezza ai governi di
render conto di condotte che non rispettino gli indirizzi codificati
(consistano essi nella mancata apertura di servizi pubblici al capitale
privato, nella conservazione di qualche regola di salvaguardia
nel mercato del lavoro, nel mantenimento di imprese produttive
o cespiti patrimoniali nella sfera statale, nell’insufficienza – per
definizione tale – della riduzione delle tasse e della spesa pubblica,
e così via).
Da ultimo, anche per ciò che riguarda lo Stato proattivo
non si può dire che abbia operato un completo ritiro. In quegli
ambiti di azione che non sono stati travolti dalla pressione alla
deregolamentazione, dalla forza finanziaria della globalizzazione
e dalla sfida della competitività che lo ha investito, lo Stato ha
ricavato un’area di attività regolatoria e di indirizzo, verso cui
ha riorientato la sua forza. Tende, cioè, a organizzare il mercato
e fissarne la logica in norme giuridiche e comportamentali e in
organizzazione burocratica e tecnocratica, che nel loro insieme
estendono la competizione come principio oltre le frontiere
tradizionali. Esce da alcune funzioni e ne sviluppa altre. Rinuncia
a una presenza più estesa e all’intervento discrezionale, e lascia al
comportamento degli agenti nel mercato il compito di condurre alle
ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico
finalità desiderate, con l’idea che l’ambito che gli appartiene sia in
primis quello di determinare attivamente le condizioni di successo
per l’azione privata (imponendo la concorrenza a tutti i livelli). Lo
Stato nazionale non scompare, specie dalla vita microeconomica e
microsociale, in un certo senso diventa più pesante e burocratizzato
in questa sua missione di agente della competizione, ma certo
rinuncia a esercitare una sua volontà di controllo sulle risorse e sulla
loro distribuzione, o a condizionare i comportamenti delle imprese
per raggiungere fini comuni, e si riserva – in sintonia con élite
dominanti non più disposte a mettere in opera programmi estesi di
funzioni collettive – un compito sussidiario e complementare alla
nuova logica. Esce sostanzialmente dalle grandi decisioni. Ogni
fantasia o immaginazione sociale è bandita. Le regole vengono
adattate o lasciate alla contrattazione tra parti. Le politiche dei redditi
non sono più l’aspetto dominante della conduzione economica, ma
cedono al mercato e alla concorrenza gran parte del loro ruolo di
disciplinamento delle spinte centrifughe della società.
Eppure sarebbe sbagliato dire che lo Stato nazionale ‘è morto’
e non potrebbe avere altre funzioni. Le prerogative che conserva non
sono poche o insignificanti pur con le limitazioni del suo agire in
un ambito globalizzato e (per i paesi europei) di unione economica
e monetaria. E sono prerogative che spaziano dalle funzioni
amministrative, al modo di concepire la rappresentanza, ai criteri
di tassazione, alla regolazione dei beni pubblici, all’allocazione
della spesa, al tipo di compromesso sociale, oltre che ai temi della
sicurezza, dell’immigrazione, e delle micro-costruzioni sociali ecc.
Perché le leve disponibili sono state così poco azionate in direzione
di un riequilibrio dei poteri e di interazione con logiche diverse?
5. La scomparsa del conflitto
È qui che interviene l’indebolimento del conflitto sociale. Per
lo meno questa è una ragione che troviamo guardando il quadro
interno ai singoli paesi occidentali. Ma poi va dato peso anche alle
ragioni per cui non siano state ricreate istituzioni capaci di esercitare
un contrappeso sul piano sovranazionale.
Nell’epoca del ‘compromesso socialdemocratico’ il conflitto
principale si era svolto attorno alla forza e al potere di coalizione
del proletariato industriale organizzato e al partito politico che lo
rappresentava (ma che aveva anche assicurato che attorno a quel
nucleo sociale si formassero le necessarie coalizioni). Quel tipo di
partito aveva costituito, col suo peso nella società e sullo Stato,
l’antidoto a che il mercato (e le classi che esso beneficia e a cui dà forza)
potessero stabilire un ordine unilaterale. Era conseguentemente
stato un nucleo di resistenza e di riequilibrio rispetto agli esiti dei
processi spontanei.
Come è ben noto, in virtù dei mutamenti tecnologici, della
crescente frammentazione e articolazione sociale che quei mutamenti
provocano, della scala mondiale dei processi di produzione, della
competizione con i salari ‘cinesi’ e della incapacità di reazione che
gli sviluppi indesiderati hanno trovato nelle politiche pubbliche
– il lavoro è diventato nel capitalismo che si afferma in questa
parte del mondo sempre più marginale e disomogeneo nella
produzione e nello scambio. Nuovi spazi di sostituzione e pressione
competitiva sulla forza lavoro si aprono alle imprese (con lavoro
irregolare, temporaneo, non sindacalizzato e sindacalizzabile, con
la minaccia di trasferimento all’estero, con le esternalizzazioni,
in primo luogo dei servizi). Sono sviluppi che si verificano in
assenza di una regolazione politica dei processi e dove le istituzioni
preposte tendono ad accettare o subire la sfida/imperativo della
globalizzazione. Nell’insicurezza, parcellizzazione, ricatto, perdita
di rappresentanza gli stati subalterni perdono identità.
Eppure, dissolto
(politicamente e numericamente)
il nucleo centrale delle coalizioni
che aveva sostenuto i diritti di
cittadinanza ed esercitato una
capacità di resistenza, la società
occidentale ha moltiplicato le figure
le cui condizioni relative e il cui
orizzonte psicologico sono peggiorati
con la globalizzazione, sebbene ciò sia avvenuto con caratteri di
difficile raccordo tra situazioni diverse. Spaccata socialmente in
due, la piramide sociale non si è spaccata altrettanto politicamente
generando un motore di domande collettive. È divenuta difficile
una identificazione tra loro delle varie figure che la compongono;
identificazione, che è sempre una costruzione culturale e politica,
Ne l l ’ i n s i c u r e z z a ,
p a r c e l l i z z a z i o n e ,
r i c a t t o , p e r d i t a d i
rappresentanza gli stati
subalterni perdono identità
Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico
non una confluenza spontanea. Se la voglia di riscatto collettivo,
vale a dire quel riscatto demandato alle conquiste nel processo
istituzionale e legislativo da ottenere dentro un comune progetto
politico, si attenua nella società, in circolo vizioso, il portatore
potenziale di quel progetto politico (il partito e sindacato) si svuota
di alimento e vede degradare la sua offerta politica e la sua forza.
Viene progressivamente meno la sua funzione di rappresentanza e
di mediazione verso le istituzioni pubbliche di pezzi della società,
in virtù della quale larghi strati della popolazione avevano potuto
agire nella sfera politica e trovare in essa elementi di integrazione
e di soddisfazione delle proprie istanze. Vengono meno coalizioni
capaci di sollecitare gli strumenti della politica per costringerla ad
attivarsi.
6. L’Europa per la sua parte
Alla domanda del perché gli strumenti della politica siano
rimasti inerti e perdenti c’è anche una risposta che guarda fuori
dallo Stato nazionale e, in Europa, alla costruzione europea. Non
si tratta solo dell’azione specifica della istituzione sovranazionale
cui si è ceduta sovranità, perché le stesse prerogative che ancora
attengono allo Stato nazionale acquistano forza e incidenza nel
loro esercizio politico se lo Stato nazionale si muove nel solco di
Stato sovranazionale che crei un contesto favorevole all’esercizio
politico delle leve che ancora rimangono nella sua responsabilità.
Ma questo contesto non vi è stato e l’Unione Europea non è stata
in grado di riequilibrare le leve dei poteri e regolare in tal senso il
processo politico e sociale. Tanto meno, capace di imporre passi in
questa direzione a livello mondiale.
Eppure, è su scala europea che i paesi continentali
avrebbero potuto riappropriarsi effettivamente della forza dello
Stato: uno Stato capace di ritrovare le prerogative che ha avuto nel
dopoguerra, che oggi, per non dissolversi nella globalizzazione, ha
bisogno di un livello sovranazionale di poteri pubblici per garantire
l’efficacia di una politica sociale e di un intervento discrezionale
nella sfera produttiva e industriale; per il mantenimento di una
spinta della domanda che possa riavvicinare il traguardo della
piena occupazione; per stabilire regole di condotta del capitalismo
e disciplinarlo verso una responsabilità fatta di diritti di terzi e forza
sociale di questi ultimi. Solo grandi stati possono tenere leve di
scelte discrezionali (relativamente) libere e affrontare con possibilità
di successo problemi e attori che spesso sono globali.
Tutto questo non è avvenuto (o avvenuto in modo molto
parziale e insufficiente) e sia la costruzione istituzionale e sia le
scelte politiche dell’Unione Europea, figlie del pensiero economico
dominante, hanno puntato tutte le carte in modo ossessivo su
concorrenza, flessibilità e imbrigliamento della presenza pubblica
nell’economia, con esiti che non possono che essere definiti
palesemente deludenti, e che ciononostante non hanno portato a
una seria revisione dei criteri, né impedito che le stesse politiche
venissero reiterate acriticamente. Così l’assetto opprimente e
costrittivo del capitalismo contemporaneo ha potuto formarsi
indisturbato e rafforzarsi su sé stesso nel cono di una visione
che riteneva, per definizione, la crescita un puro derivato della
competizione produttiva (anche tra sistemi) e della flessibilità dei
mercati e era convinta che la stessa crescita si sarebbe sostenuta da
sola attraverso politiche che spianassero la strada al capitale privato.
L’Unione ha dettato le regole per l’apertura dei singoli mercati,
ma lasciato senza regole comuni (e quindi campo di anarchia e
concorrenza al ribasso) gli ordinamenti dei paesi membri in materia
di fisco e finanza: i gangli più sensibili, cioè, in cui la competizione
non poteva che essere al ribasso.
7. Una reazione sacrosanta, ma distorta
Se questo è il quadro di oltre un trentennio che segue la svolta
degli anni ‘80, va anche detto che la storia si vendica e sia il conflitto
sia la forza dello Stato si riaffacciano. Lo fanno in una forma nuova,
distorta dal ‘punto di partenza’, vale a dire, dalle trasformazioni su
cui si innestano, avvenute negli assetti di potere, nei cambiamenti
antropologici e culturali, nel tipo di regolazione sociale che si è
affermato, nel modo di strutturarsi della produzione e della finanza
mondiali. L’emarginazione di larghi strati della popolazione, la
privazione di rappresentanza sociale, l’insicurezza sul futuro, oltre
che l’estensione delle diseguaglianze e i problemi occupazionali
hanno finito per generare una rivolta che si esprime direttamente,
Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico
ma anche si appella a un potere politico e invoca il ritorno dello
Stato come protagonista della vita collettiva e del riequilibrio dei
poteri e delle logiche. Nel contesto che si è generato hanno fatto
breccia, come è noto, quei movimenti che hanno assunto connotati
anti-establisment. Ma il processo è in evoluzione e può assumere
varie direzioni da cui dipenderanno le direzioni della storia.
Il ritorno dello Stato è nel senso di un recupero di
discrezionalità politica ma non necessariamente di capacità di
riequilibrare i poteri all’interno delle singole società occidentali. Ci
sono profili consolidati del capitalismo contemporaneo finanziario
e produttivo (globalizzato) che hanno una forte solidificazione,
consistano essi nella strutturazione della produzione globale per
agglomerati planetari e catene del valore oppure nel presidio che
una finanza sempre più estesa e pervasiva riesce ad esercitare su
‘deviazioni’ delle politiche economiche. Finché il quadro non è
scalfito, è difficile che cambi anche il tipo di regolazione sociale
che vede i lavoratori nettamente indeboliti e divisi rispetto ai
processi di mercato e a un progresso tecnologico che ne frantuma la
composizione, oltre a dividerli in vincitori e perdenti. Eppure, non
bastano gli elementi di resilienza a dare un quadro di continuità
(ho trattato il tema nel saggio Il futuro del neo-liberismo tra resilienza e
trasformazione, «ItalianiEuropei», n. 2, 2019).
Ciò che non lo rende più identico è il fortissimo indebolimento
della legittimazione del sistema seguito a politiche incapaci di
affrontarne le conseguenze sociali generate dalla crisi del 2007.
È vero che la regolazione sociale non sta cambiando (soggetta a
condizioni che la costringono e alla permanenza di un panorama
di produzione e finanza essenzialmente integro), ma il quadro
soggettivo cambia e pone in seria discussione la legittimazione di
questo tipo di società capitalistica. La frattura sociale appare oggi
meno uno stato di natura e più un risultato del processo produttivo
guidato dal predominio del mercato.
Su cosa fondasse la legittimazione della società prodotta dal
neo-liberalismo è un mistero, mentre è chiaro dove essa trovasse
fondamento nell’era socialdemocratica. Vi era allora la capacità
di larghe masse di incidere sui meccanismi produttivi e sociali di
quel regime attraverso l’azione collettiva e la rappresentanza; le
istituzioni erano permeabili alle istanze provenienti dal basso e vi
era la convinzione che lo Stato avrebbe corretto l’agire del mercato
nell’interesse della collettività. Quella di cui ha goduto l’era
neoliberale non è spiegabile senza ricorrere a elementi culturali
che avevano diffuso il convincimento dell’assenza di alternative,
di un modo di governarlo appartenente all’ordine naturale delle
cose, della oggettività delle caratteristiche salienti del sistema
produttivo e sociale e della sua strutturazione nell’allocazione di
potere in una élite economica, nonché della responsabilità personale
nell’insuccesso personale. Oggi il capitalismo globalizzato non
appare più in Occidente una forza dinamica tale da sostenerne i
suoi miti mentre maturano orientamenti di vero e proprio rigetto
dei suoi esiti.
Su quest’onda rinasce un’idea di uno Stato meno costretto
nella sua azione e più attivo e più legittimato a usare la sua
forza politica. Questo, seppure non coincida oggi con un vero
ribaltamento dei rapporti di forza nella società, apre una dinamica
importante. In parte sono le stesse forze liberaldemocratiche (che
ne avevano avallato il ritiro) a essere indotte a riesumare i poteri
pubblici in virtù della spinta delle cose, ma, in realtà, chi si è
impossessato della prospettiva sono le forze sovraniste, ostili alla
globalizzazione e propense a portare nella ribalta politica un non
meglio identificato ‘popolo’. Sappiamo bene che la forza dello Stato,
da queste rivendicata, non è diretta a sfidare la logica di potere
sottostante, o scontrarsi con la popolazione più abbiente, a garantire
i diritti sociali compressi dal regime neoliberale, a vincolare la
libertà economica e di mercato a fini collettivi o a operare una seria
redistribuzione della ricchezza. È intesa piuttosto come difesa dai
migranti, come svincolo da regole comuni, come attiva contestazione
ai valori dell’occidente giudicati decadenti e lassisti, come messa in
discussione dello stato di diritto e dei diritti delle minoranze, oltre
che orientata a indirizzi di detassazione e ostile ai sindacati. Tuttavia,
le stesse forze che oggi raccolgono la protesta non possono risentire
di una crisi di legittimità che tocca anche le politiche tradizionali
per cui è improbabile che esse possano confermare com’è un
assetto neoliberista di fronte a un pubblico ostile agli effetti che
produce. Questo fa pensare che la pressione popolare e domanda di
protezione, da un lato, e le esigenze di mantenimento del consenso,
dall’altro, portino a modificare significativamente il quadro delle
politiche, in un contesto che non potrà essere un ritorno all’indietro.
E fa pensare che questo diventi anche il terreno su cui si sposta la
Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico
competizione politica. Abbiano o no i movimenti di protesta la
forza politica di far allontanare dal regime neo-liberale (una grande
interrogativo per il futuro), dovrà comunque essere garantita una
qualche redistribuzione, anche preventiva, e dovrà la forza dello
Stato essere indirizzata anche a stabilire una statualità contro i
poteri che agiscono nella sfera economica, oltre che a moderare e
contenere gli effetti delle politiche neo-liberiste con pratiche che se
ne discostano e con una difesa dello stato sociale. E questo diventerà
necessariamente direttrice di tutte le forze politiche.
8. La prospettiva del conflitto
Nella stessa forma distorta in cui ritorna lo Stato, riappare il
conflitto. Quanto meno si apre una dinamica importante anche su
questo piano. Se è vero che una certa affermazione del populismo
è avvenuta attraverso il consenso elettorale, è pure vero che anche
il voto può essere espressione di una rivolta, la quale riapre una
dialettica sociale e impone un’agenda.
Chi vorrà interpretarla dovrà porsi anche sul piano della
creazione di una identità collettiva e del rinnovamento della
politica. Finora i populisti hanno dato su entrambi i piani una loro
risposta, per quanto distorta, riempiendo, tuttavia, dei buchi reali.
Hanno ricreato l’identità in una identificazione col leader in una
forma di delega e rappresentanza, e, ancora nella contrapposizione
all’establishment. E dall’altra parte, hanno contribuito
all’allargamento della partecipazione politica e nel costringere il
sistema politico ad adattarsi al cambio sociale. Chi vorrà competere
dovrà offrire a sua volta una identità
di altro tipo, connotata socialmente,
dovrà offrire una rappresentanza e
contribuire al rinnovamento della
politica. Questo stimolo che il
sovranismo porta, interpretando un
sentimento politico, verso il ritorno in campo della politica e del
conflitto non sottovaluta che si manifesti in quei movimenti integrato
costituzionalmente con il rifiuto del diverso (spesso il razzismo), col
fastidio della magistratura, con autoritarismo e principi illiberali.
La storia presenterà delle svolte. Quel sistema scaturito dalle
Nella stessa forma distorta
in cui ritorna lo Stato,
riappare il conflitto
dinamiche degli ultimi quarant’anni, così sbilanciato nei rapporti
di forza e difeso nelle sue logiche e nei suoi esiti, non si tiene più
nella sua totalità e nelle sue contraddizioni e non potrà mantenere
a lungo la coesistenza tra le parti resilienti e le parti che tendono
disordinatamente a modificarlo (vedi il saggio sopra citato). Nella
dinamica che ne segue si determinano movimenti della storia, il cui
corso dipende da che tipo di crisi ne potrà sorgere e da chi sarà in
grado di catturare e dare una prospettiva a questa frattura culturale,
che è il motore delle cose in questa fase e difficilmente recederà.
Dipenderà, in altre parole, da chi sarà capace di costruire una
prospettiva politica volta a portare masse di persone che vivono in
modo differente il disagio di questa società a essere forza di governo,
a riconoscersi reciprocamente, far pesare assieme la propria
presenza, cultura e identità nel tessuto istituzionale, elevandosi a
protagoniste consapevoli del proprio riscatto.