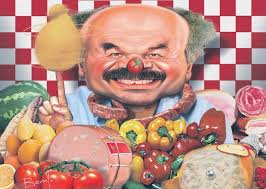Fonte: il megafono quotidiano
Url fonte: http://ilmegafonoquotidiano.it/news/le-cornucopie-del-consumismo
LA DANZA DELLE MOZZARELLE – di WOLF BUKOWSKI – ed. ALEGRE
intervista a Wolf Bukowski di Samir Hassan e Alessandro Barile
Un’intervista con Wolf Bukowski, autore del volume «La danza delle mozzarelle», una serrata e documentata critica del modello Eataly, i templi dell’alimentazione di qualità fondati sulla precarietà lavorativa e sui rapporti di dipendenza dei piccoli produttori.
Nella prime pagine de La danza delle mozzarelle (Edizioni Alegre), Il libro di Wolf Bukowski, blogger e «esperto» di cultura alimentare, compare una lista di nomi e sigle fin troppo note. Ci sono il Partito Democratico, Slow Food, Matteo Renzi, Lega Coop, Benetton, Eataly: sono loro i protagonisti del volume. Se si trattasse di una trama lineare e fiabesca sarebbero i cattivi di tutte le storie che iniziano con «c’era una volta». I personaggi con le sopracciglia aggrottate e un ghigno sinistro, perennemente arrabbiati. E arrabbiati lo sono, perché le pagine scritte da Wolf Bukowski, vegetariano seppur bolognese, (s)parlano di loro. E di come la retorica del consumo che stanno producendo sia uno tsunami da fermare prima che infranga la cultura alimentare di qualità.
Un’inchiesta, una denuncia, una serrata critica politica: come definirebbe il suo libro?
Non si tratta di un’inchiesta. Mi piace pensarla, semmai, come una storia del presente che si pone l’obiettivo di mettere a nudo il punto di vista in base al quale Petrini e Farinetti hanno costruito il proprio impero economico: cambiare il modo di mangiare significa cambiare la società. In meglio.
Sono molti gli spunti che hai trattato in questo libro. Da dove e quando nasce l’idea di questa pubblicazione?
L’occasione più prossima che ha dato il là al progetto editoriale (curato da Wu Ming1, consulente editoriale della collana «Tempi moderni» delle edizioni Alegre, NdR) è stato un post che ho fatto su Giap, il sito dei Wu Ming, a proposito di Eataly a Bologna, del progetto Fico (Fabbrica Italiana Contadina), della «Disneyland del cibo». Poi tutto è andato come ha recentemente raccontato Wu Ming 1: la necessità di un ragionamento complessivo, di un filo che tenesse uniti il renzismo e il farinettismo, di una critica serrata alla precarietà che c’è dietro la facciata di queste operazioni, quella stessa manodopera a basso costo che ritroviamo nella vicenda dell’Expo di Milano».
Nella ricostruzione che lei fa – che segue un filo cronologico dagli anni ’80 ad oggi – dopo i passaggi sulla Torino di Eataly, sulla Bologna terra di conquista della Coop, affronta anche l’Expo 2015 di Milano…
È stato fin troppo facile dedicare la parte finale di questo ragionamento alla questione dell’Expo. Anzitutto perché Slow Food è dentro questo progetto che ha proprio tutte le caratteristiche del grande evento come siamo soliti intenderlo noi in Italia: cementificazione selvaggia, rapporti lavorativi all’insegna della precarietà, esaltazione del lavoro volontario come paradigma e sperimentazione di nuove forme di schiavitù salariata. Ma soprattutto ci è dentro in maniera trainante, prima avendo sottoscritto il manifesto dell’Expo dei Popoli che vuole «rappresentare la complessità della società civile impegnata sui temi della sovranità alimentare, del diritto al cibo, all’acqua, alla terra e alle altre risorse». Poi per l’adesione critica all’Expo: nel dicembre 2013 presentano la partecipazione all’Esposizione Universale di Slow Food, cinque mesi dopo Petrini ritratta definendo Expo una «ferita sul territorio», fino ad arrivare a giugno scorso quando annuncia la partecipazione critica.
Tra i punti di partenza del suo ragionamento c’è il recupero della critica che Gramsci fece a Feuerbach a proposito dell’affermazione «l’uomo è ciò che mangia». In un certo senso la critica di Gramsci oggi sarebbe rivolta a Farinetti, non crede?
La critica gramsciana è di un’attualità incredibile. Ciò che quella narrazione tossica ignora è che una società migliore, più equa, non passa dal cambio delle abitudini alimentari, come se questo fosse un processo meccanico. La possibilità di cambiare il modello di consumo è legata alla possibilità economica di consumare. Le situazioni di sfruttamento, i rapporti produttivi che ancora oggi regolano le azioni di mercato, non permettono a chi lavora di accedere a quel paniere così esoso, così moralmente giusto.
Facendo un giro tra gli scaffali di Eataly sembra quasi che debba essere migliore ed equo ciò che costa a caro prezzo…
Purtroppo si. Il concetto di migliore non può essere legato esclusivamente a parametri economici. Insomma, il fatto è che non si può dire che se spendo di più contribuisco a rendere migliore questo mondo. Non è vero, anche perché persiste un’iniquità che non è legata solo al fattore alimentare, ma riguarda l’accesso al reddito, al diritto all’abitare e a tanto altre cose puntualmente ignorate.
Il titolo del testo è davvero curioso, e sembra nascondere una certa ilarità. Quali i motivi che l’hanno portata a sceglierlo?
Verso la fine del libro racconto un aneddoto che è indicativo di come questo mondo migliore ci viene spacciato e dell’importanza del modo in cui viene raccontato. Lo scorso anno, alla Festa dell’Unità di Bologna, un agricoltore siciliano chiese a Farinetti come fosse possibile che il grossista pagasse 70 centesimi per la sua uva, ritrovandola poi nei negozi a prezzo quintuplicato. Per tutta risposta, Farinetti ignorò la domanda e iniziò una lunga filippica sul concetto di narrazione, affermando che un prodotto non ha valore se tu non si è capaci di narrarlo. Aggiunse poi l’esempio della mozzarella di bufala, lavorata al mattino e rivenduta nel giro della giornata per mantenerne la freschezza: secondo lui l’immediatezza della transazione sarebbe stata frutto di una migliore narrazione del prodotto.
Questo ci dice due cose. Prima di tutto, Farinetti imputa agli agricoltori l’incapacità di narrare e quindi di saper vendere i prodotti al giusto prezzo. Un modo come tanti per far pesare la gravità dello sfruttamento contadino su chi ne è egli stesso vittima. In più è un modo subdolo di narrare anche i rapporti sociali che risiedono in una merce. Raccontare la storia delle mozzarelle è stato un modo per eludere i processi materiali di sfruttamento che risiedono dietro quella produzione di merce, un modo per far si che quei rapporti sociali fossero in linea con l’interesse padronale.
Una delle caratteristiche forti del libro è la critica a quella sinistra complice di aver partecipato allo sdoganamento del Farinetti-pensiero. E tra queste complicità viene citata anche quella del «Gambero Rosso», nel 1986 inserto de il manifesto e poi diventata attività editoriale che ha preso un’altra strada..
Negli anni Ottanta la sinistra italiana si cullava nell’idea che il conflitto fosse sparito, che c’erano ancora piccole sacche di sfruttamento da combattere, ma che il più fosse fatto. In questo senso, il Gambero Rosso ha partecipato a questo processo in cui l’ossessione per il cibo ha assunto un significato di redenzione e appagamento taumaturgico. Nel testo però faccio notare come questo passaggio epocale, che in nuce nascondeva il germe di quello che poi è diventato in Slow Food, non fosse stato privo di ripercussioni. Sia Petrini che Stefano Bonilli (allora direttore del Gambero Rosso, Ndr) raccontano come tra molti redattori e lettori del giornale serpeggiava una sorta di malumore. Bonilli, in particolare, cita le testimonianze di alcuni edicolanti secondo cui «c’era gente che comprava il manifesto, teneva l’inserto e buttava il giornale. Succedeva anche il contrario per la verità. Cioè tenevano il giornale e buttavano l’inserto». Posso confessare che da adolescente io ero uno di quelli che teneva in tasca solo il giornale.
Le radici antiche di un produttivismo dal volto benevolo
recensione di Samir Hassan e Alessandro Barile
L’uso di metafore sul cibo e sulla nutrizione rappresentano un esercizio stilistico che aiuta a comprendere meglio i tempi in cui viviamo. Tutto sembra ruotare intorno al mangiare: siamo letteralmente invasi non solo da programmi tv e via internet legati al cibo, ma da una retorica che trasforma un certo modo di mangiare in un certo modo di pensare e di vivere. Mangiare davanti la Tv, mentre assaporiamo reality sul cibo, sul trend cooking. Oggi come ieri ignoriamo che l’accesso al cibo e ad una alimentazione variegata sono la proiezione nella società del nostro status, attraverso cui leggere e collocare socialmente ed economicamente le nostre abitudini alimentari. Mangio tanto e di più, perché posso. Perché non mangiare anche meglio, allora?
Dietro questa confusa convinzione si sviluppa da un paio di decenni il terreno su cui, a partire dalla metà degli anni Ottanta, le tesi di Slow Food e di Eataly ha trovato consensi. Una costruzione che ha lavorato sull’immaginario prima ancora che sulle abitudini alimentari della gente, e che Wolf Bukowski, bolognese e guest blogger di Giap (sito dei Wu Ming), ha preso di petto nella suo libro La danza delle mozzarelle (Alegre, euro 14).
Nella ricostruzione che Bukowski mette a punto viene chiamata sul banco degli imputati la narrazione di un modello scientemente viziato dall’assunto che oggi, in Italia, la spesa per l’alimentazione è in forte calo, segnando una forte controtendenza con quanto ad esempio avveniva nel decennio degli anni Settanta. L’autore, e qui risiede uno dei maggiori pregi della sua documentata arringa, sgonfia la portata di questa vulgata puntando fin dalle prime pagine non solo a smentirla con numeri e fonti, ma anche smascherando l’idea di fondo di questo nuovo produttivismo benevolo: non si mira tanto ad una cambio radicale dei modi di consumo, quanto ad un incremento del consumo stesso. In altre parole, non c’è nessuna «etica rivoluzionaria» dietro le strategie di marketing improntante sulla logica «seminare, distribuire e consumare in maniera buona, pulita e giusta», a maggior ragione se non avviene nessun meccanismo di rottura con le pratiche di sfruttamento e precarizzazione che si articolano nella filiera produttiva. Ed è proprio nella parte introduttiva del testo che Bukowski centra il punto, richiamando la critica mossa da Gramsci all’affermazione di Feuerbach «l’uomo è ciò che mangia».
D’altronde, proprio al modello produttivo inerente il brand Eataly afferisce la contraddizione principale tra una narrazione apparentemente progressista e una sostanza concretamente simile al resto della produzione demodé. Dietro la patina nuovista, farinettiana, si celano i soliti rapporti di lavoro precario, sfruttato, mai indeterminato e mai garantito, ma sempre just in time. Il tutto al fine di una produzione d’elite, circoscritta a quel pezzo di società che può permettersi di entrare e acquistare prodotti economicamente alla portata di pochi. Un modello che si è puntualmente trasposto nella costruzione fisica e immaginaria dell’Expo, su cui oggi si sta interrogando il variegato mondo della sinistra: non a caso il Jobs Act renziano non fa altro che recepire quelle sperimentazioni contrattuali attuate nel «laboratorio Expo».
Quella galassia che Wolf Bukowski, all’inizio del libro, ha citato in giudizio perché complice di aver sdoganato le retoriche su cui poi il modello i Farinetti ha proliferato. In questo testo c’è dunque un’analisi che punta a svelare il fatto che la retorica dietro il modello di Eataly è un vero e propri inno al consumismo. Di come la sinistra, intesa come patrimonio comune, possa oggi fare opera di demistificazione ai tempi del turbocapitalismo. Una sinistra che dovrà fare tesoro di riflessioni come quelle che Bukowski ha avuto il coraggio di condividere con lei, andando oltre la patina del politicamente corretto, anche quando riguarda un tema apparentemente secondario come il cibo.