Feria d’agosto, pubblicato nel 1946, è una raccolta di ventinove racconti tutti narrati in prima persona, molto suggestivi e curati nella prosa, divisi in tre sezioni, ognuna delle quali è dedicata ad un luogo e ad una diversa fase della vita.
Pavese da poco aveva pubblicato il suo primo romanzo Paesi tuoi (1941), ma aveva già scritto e non pubblicato. Il carcere (1939), La bella estate (1940) e La spiaggia (1941).
Feria d’agosto è un libro di transizione, vengono messi a fuoco intuizioni critiche o prese di coscienza attinenti alla poetica e maturazione di Pavese, ponendola in rapporto con i suoi successivi sviluppi.
Il libro è diviso in tre parti: Il mare (l’adolescenza), La città, (l’età matura) La vigna, dove il divario fra uomo e ragazzo si fa dramma nel ricordo di un’età divenuta mito.
Nella prima parte, i protagonisti sono tutti adolescenti con i problemi della loro età: quando si è ancora divisi tra il gioco e la voglia di confrontarsi in contrapposizione agli adulti, quando alla persistenza di alcune paure infantili fa da contraltare una nascente baldanza derivante dal desiderio di nuove scoperte. “È la parte dedicata al mare, un mare che incarna la voglia di crescere e di scoprire il mondo, che rappresenta una meta agognata da raggiungere per uscire finalmente dal piccolo universo in cui si è relegati e in cui usanze, riti e abitudini si ripetono rassicuranti ma al contempo monotoni.” (Enrico Caramuscio)
Appartengono a questa parte il primo racconto pubblicato, Il nome, dove i due ragazzi che se ne vanno per le colline temono che la vipera venga a conoscere il nome di uno di loro, gridato dalla madre in ansia, e poi lo vada a cercare. E “Fine d’agosto” dove compare in modo inquietante l’ossessione dello scrittore per la donna/carne: “Ma io ormai non potevo più perdonarle di essere donna: una che trasforma il sapore di vento in sapore di carne“
da Feria d’agosto – Cesare Pavese
Il nome
Chi fossero i miei compagni di quelle giornate, non ricordo. Vivevano in una casa del paese, mi pare, di fronte a noi, dei ragazzi scamiciati – due – forse fratelli. Uno si chiamava Pale, da Pasquale, e può darsi che attribuisca il suo nome all’altro. Ma erano tanti i ragazzi che conoscevo di qua e di là.
Questo Pale – lungo lungo, con una bocca da cavallo – quando suo padre gliene dava un fracco scappava da casa e mancava per due o tre giorni; sicché, quando ricompariva, il padre era già all’agguato con la cinghia e tornava a spellarlo, e lui scappava un’altra volta e sua madre lo chiamava a gran voce, maledicendolo, da quella finestra scrostata che guardava sui prati, sui boschi del fiume, verso lo sbocco della valle. Certe mattine mi svegliavo all’urlo lamentoso, cadenzato, di quella donna da quella finestra. Molte vecchie chiamavano così i figli, ma il nome che faceva ammutolire tutti e che in certe ore echeggiava esasperante come le fucilate dei cacciatori, era quello di Pale. A volte anche noialtri si gridava quel nome per baldanza o per beffa. Credo che persino Pale si divertisse a urlarlo.
Così, il giorno che salimmo insieme sulle coste aride della collina di fronte – prima, nelle ore bruciate, avevamo battuto il fiume e i canneti – non so bene se fossimo soli, io e Pale. È certo che il mio socio aveva i denti scoperti e la testa rossa, e me ne ricordo perché gli raccontavo che il leone, che vive nei luoghi aridi, aveva i denti come i suoi e il pelo fulvo. Quel giorno eravamo agitati perché l’avevamo impiegato a fare una ricerca metodica della serpe. C’eravamo infradiciati fino al ventre e arrostita la nuca al sole; qualche rana era schizzata via da sotto le pietre rimosse, le mie caviglie erano tutte un livido. A Pale poi colava dai denti il sugo verde di un’erba che aveva voluto masticare. Poi, nel silenzio delle piante e dell’acqua, s’era sentito fioco, ma nitido, sul vento un urlo di richiamo.
Ricordo che tesi l’orecchio, caso mai chiamassero me. Ma l’urlo non si ripeté. Lasciammo, poco dopo, la bassa del fiume e salimmo la costa, dicendoci che andavamo per prugnoli, ma ben sapendo – io, almeno, e il cuore mi batteva – che lo scopo questa volta era la vipera. Fu mentre salivamo il sentiero tra i ginepri che presi a parlare, imbaldanzito, dei leoni. Mi ero rimesso le scarpe, quasi a scongiurare con un gesto da bravo ragazzo i pericoli impliciti nella resa di conti serale. Fischiettavo.
– Piantala. Non è così che si chiama la vipera, – brontolò il mio socio, fermandosi.
C’eravamo muniti di due verghe a forcella, e con queste dovevamo inchiodare la bestia e ammazzarla. Se anche nell’acqua eravamo andati in parecchi, sono certo che quel sentiero lo salimmo noi due soli. Pale -ben diverso da me – camminava scalzo sui sassi e sugli spini, senza badarci. Volevo dirglielo, quando d’improvviso si fermò davanti a un roveto e cominciò a sibilare piano piano, sporto in avanti, dondolando il capo. Il roveto usciva da uno scoscendimento roccioso, e di là si vedeva il cielo.
– Era meglio se acchiappavamo la serpe, – dissi, nel silenzio.
L’amico non rispose, e continuò a sussurrare, come un filo d’acqua a un rubinetto. La vipera non usciva.
Ci riscosse un clamore improvviso sul vento, qualcosa come un urlo o uno scossone. Di nuovo, dal paese, avevano chiamato: era la solita voce, lamentosa e rabbiosa: «Pale! Pale!»
Pensai subito ai miei di casa. Pale s’era fermato, a testa innanzi; dritto su una gamba sola, e mi parve che facesse una delle sue smorfie diaboliche. Ma ecco che il silenzio s’era appena rifatto, e di nuovo la voce – inumana in quel salto d’aria – strillò «Pale! Pale! » E fu allora che il socio gettò, con rabbia il vincastro e disse in fretta: – Quei bastardi. Se la vipera sente il nome mentre la cerchiamo, poi mi conosce.
– Vieni via, – dissi con un filo di voce. La vecchia maledetta continuava a chiamare. Me la vedevo alla finestra, sbucare ogni tanto con un lattante in braccio e cacciare quello strillo come se cantasse. Pale mi prese un bel momento per il polso e gridò « Scappa ! » Fu una corsa sola fino alla piana; ci gridavamo «La vipera! » per eccitarci, ma la nostra paura – la mia, almeno – era qualcosa di più complesso, un senso di avere offeso le potenze, che so io, dell’aria e dei sassi.
Venne la sera e ci trovò, seduti sui traversini del ponte. Pale taceva e sputava nell’acqua.
– Prendiamo il fresco al balcone, – dissi a Pale. Era quella l’ora che tutte le donne del paese cominciavano a chiamare questo e quello, ma per il momento c’era una pace meravigliosa, e si sentiva soltanto qualche grillo.
«Non mi hanno ancora chiamato», pensavo; e dissi:
– Perché non rispondi quando ti chiamano? Questa sera te le dànno.
Pale alzò le spalle e fece una smorfia. – Cosa vuoi che capiscano le donne.
– Davvero, se la vipera sente un nome, poi lo viene a cercare?
Pale non rispose. A forza di scappare di casa era diventato taciturno come un uomo.
– Ma allora il tuo nome dovrebbero saperlo tutte le serpi di queste colline.
– Anche il tuo, – disse Pale con un sogghigno.
– Ma io rispondo subito.
– Non è questo, – disse Pale. – Credi che alla vipera importi se fai il bravo ragazzo? La vipera vuole ammazzare quelli che la cercano…
Ma in quel momento ricominciò l’urlo di prima. La vecchia s’era rifatta alla finestra. Cigolarono le ruote di un carro e s’udì il tonfo di un secchio nel pozzo. Allora m’incamminai verso casa, e Pale rimase sul ponte.
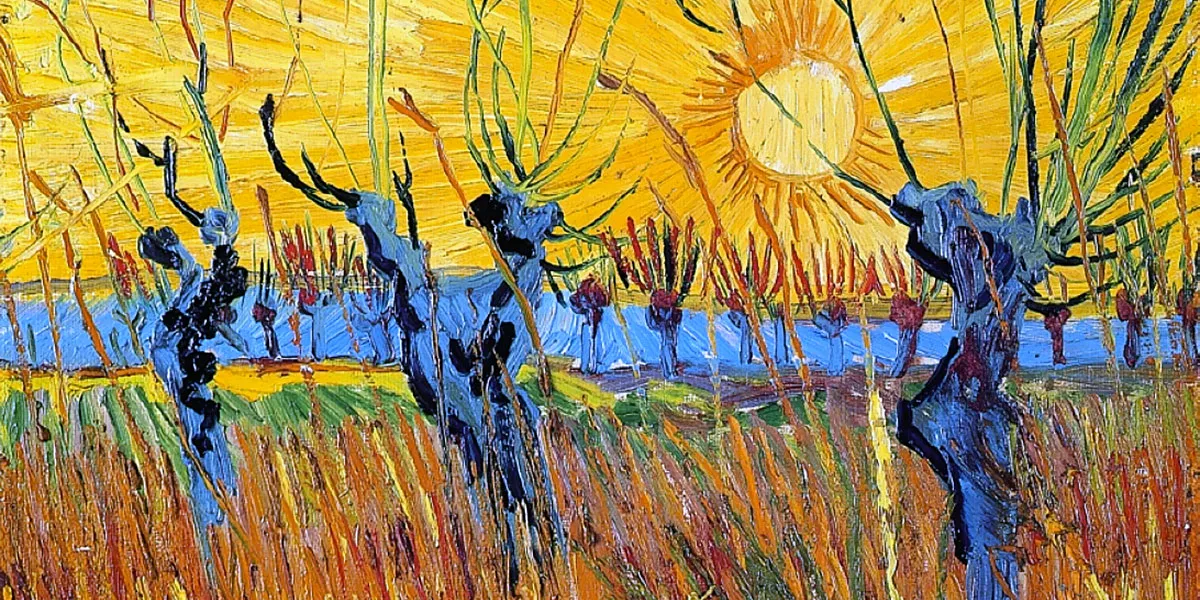
FINE D’AGOSTO
Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m’impresse su guance e labbra un’ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.
__Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c’investì un’altra folata, Clara fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un’altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscìo d’una foglia secca trascinata sull’asfalto – e dissi a Clara che salisse, l’avrei subito seguita.
__Quando, dopo un quarto d’ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l’aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell’estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c’era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte.
__Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d’indovinarlo, tanto più che l’aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara.
__Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall’infanzia. La spiaggia dove sono nato si popolava nell’estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c’erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le burrasche s’impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi.
__Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.
__C’è qualcosa nei miei ricordi d’infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l’incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un’improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti al mare. L’uomo e il ragazzo s’ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star soli.
__Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l’altro un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.
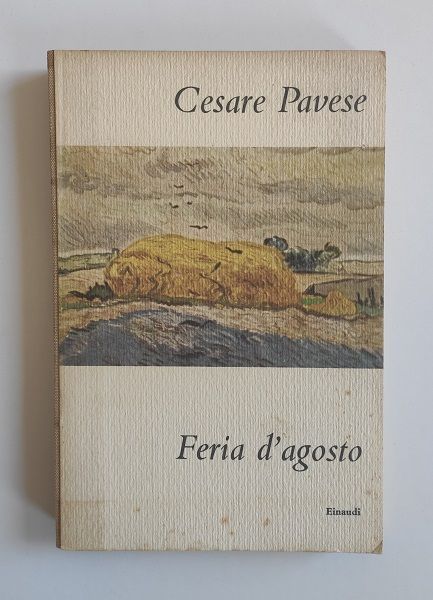
La seconda parte della raccolta ci porta a scoprire la città. Il luogo dove si fa conoscenza, esperienza. Il luogo dove la gioventù è chiamata a confrontarsi con il mondo esterno. La grande scoperta è la notte, la solitudine delle passeggiate in città nelle sere d’estate
L’estate
Di tutta l’estate che trascorsi nella città semivuota non so proprio che dire. Se chiudo gli occhi, ecco che l’ombra ha ripreso la sua funzione di freschezza, e le vie sono appunto questo, ombra e luce, in un passaggio alternato che investe e divora. Amavamo la sera, le nubi torride che pesano sulle case, l’ora calma. Del resto, anche la notte ci faceva l’effetto di quella breve penombra che inghiotte chi dal gran sole rientra in casa. C’incontravamo sull’imbrunire, ed era già mattino, era un’altra giornata tranquilla. Ricordo che la città era tutta nostra – le case, gli alberi, i tavolini, le botteghe. Nelle botteghe e sui banchi rivedo montagne di frutta. Ricordo il profumo caldo e le voci nelle vie. So dove cade a una cert’ora il riquadro di sole sul mattonato della stanza.
Di noi, invece, e delle nostre parole non ritrovo quasi nulla. So che mangiai molta frutta; che mi assopii tante volte abbracciato e abbracciando; che attardandomi a sera per via, godevo i passanti, i colori, gli istanti, sapendomi atteso. So che le mie mani e il mio corpo erano divenuti una cosa tenera e viva, come appunto le nuvole, l’aria e le colline in quelle sere d’estate. Tutto questo mi fu familiare, e direi quotidiano se il succedersi di quei giorni non mi paresse tuttora illusorio, tanto che a volte l’intera stagione mi riesce, a ripensarci, una sola giornata che vissi in comune. Questa giornata era dentro di me, e la compagnia che finì con l’estate le dava un senso e una voce. Quando ci lasciavamo non ci pareva di separarci, ma di andare ad attenderci altrove, come a un convegno, come in fondo alle vie scompare e riappare la collina. La vedevamo ogni sera coprirsi d’ombre, e ci piaceva tanto nella sua calma che divenne una delle cose della stanza, divenne parte della finestra e della via. Nella notte breve non scompariva, tant’era vicina. La giornata cominciava e finiva con lei. Mangiavamo la frutta guardandola. Adesso non resta che la collina e la frutta.
La città semivuota mi pareva deserta. Il gioco dell’ombra e del sole l’animava tanto, ch’era bello fermarsi e guardare da una finestra sul cielo e su un ciottolato. Sapere che oltre alla luce e all’ombra fresca c’era qualcosa che mi stava a cuore e rinasceva col sole e affrettava la notte, dava un senso a ogni incontro che avvenisse su quelle strade. C’erano gli alberi che bevevano il sole, c’erano i gridi delle donne, c’era un grande silenzio. Uscivo dalla stanza presentendo altri sentori e la frescura della sera. Potevo guardare e amare ogni cosa.
A volte, in tutt’altra parte della città, c’era una piazza che mi attendeva, con le sue nuvole e il suo calmo calore. Nessuno l’attraversava, nessuna finestra s’apriva, ma s’aprivano gli sfondi delle vie deserte in attesa di una voce o di un passo. Se tendevo l’orecchio, nella piazza il tempo si fermava. Era giorno alto. Più tardi, a sera, ci pensavo e la ritrovavo immutata.
In quelle sere l’estate non perdeva vigore, giacché sapevamo che ciascuno di noi pensava all’altro. Ogni incontro consueto mi toccava nel cuore questa certezza, muovendola appena, e la faceva traboccare. Allora s’increspava la luce, che vedevo come un giovane ricordo, quasi rientrassi d’improvviso in un’estate diversa, di là dai corpi e dalle voci, e la stanza che avevo lasciato mi fosse valsa come un’ombra che discreta mi riaccoglieva. Ogni cosa, accadendo, si faceva ricordo, perché accadeva dentro di me prima che fuori. Era come se la lunga giornata l’andassi facendo io, e perciò niente, della stanza e della sera, mi era estraneo; nemmeno il corpo che accoglieva il mio, e la voce sommessa.
Una sera le nuvole si addensarono, e piovve tutta la notte. Io attendevo a una finestra che non era la nostra, e gli spruzzi e le gocciole mi giungevano in faccia. Sapevo che l’indomani la luce sarebbe stata più viva e più fresca l’ombra, e non ebbi fretta di rientrare dov’ero aspettato. Era l’ultima pioggia dell’estate, e cambiò il colore della città. Avrei potuto attendere, al riparo, ma discesi sotto la pioggia e percorsi altre strade. Pensavo intensamente alla nostra finestra, ci pensavo e me ne allontanavo. La collina era in fondo alle strade, oscurata e avvicinata dall’ombra accresciuta. Vidi sotto la pioggia davanzali e portoni che avevo sempre visto nel sole. Tutto era fresco e vicino, e veramente stavolta la mia città era deserta. Traversai molte piazze. Quando rientrai, innamorato e pensando alle strade dell’indomani, trovai la stanza vuota, e tale fu fino a notte. Mi misi allora alla finestra.
Stemmo insieme ancora molti giorni, fin che durò la stagione, ma entrambi sapevamo che tutto sarebbe finito entro l’autunno. Così fu infatti.

Nella terza parte i brani sono prossimi al saggio o alla prosa d’arte. Pavese rivela la sua concezione “del mito, del simbolo o d’altro” : «Ora, da bambini il mondo s’impara a conoscerlo non – come parrebbe – con immediato e originario contatto alle cose, ma attraverso i segni di queste: parole, vignette, racconti. […] le cose si scoprono, si battezzano, soltanto attraverso i ricordi che se ne hanno.»
Lo scrittore scrive di ‘ricerca del tempo perduto’ e di ‘tempo ritrovato’ con un chiaro riferimento a Proust e nel racconto L’adolescenza scrive:
«Il giorno in cui ci si accorge che le conoscenze e gli incontri che facciamo nei libri, erano quelli della nostra prima età, si esce d’adolescenza e s’intravede se stessi. […] Nulla è mutato nelle cose e persone della nostra piccola esistenza, siamo mutati noi: attraverso lo stupore che ciò che della vita abbiamo veduto e sentito sia lo stesso che muove e accende le alte fantasie dei libri, abbiamo capito di ammirare: abbiamo scoperto, afferrato un mondo, il nostro mondo. […] Nessun ragazzo, nessun uomo ammira un paesaggio prima che l’arte, la poesia – una semplice parola anche – gli abbiano aperto gli occhi. Ognuno ripensi a un’ora estatica della sua fanciullezza, e troverà sotto l’entusiasmo e la rivelazione, la traccia di gusto, libresca o no, che la sua qualsiasi cultura gli ha segnato.»
I luoghi mitici in Pavese sono quelli dell’infanzia: un prato, una selva, una vigna. Dove sono accaduti fatti che li hanno resi unici una volta per tutte. Una vigna diventa “una porta magica”, “un teatro” dove “qualcosa d’inaudito è accaduto o accadrà”.

La vigna
“Una vigna che sale sul dorso di un colle fino a incidersi nel cielo, è una vista familiare, eppure le cortine dei filari semplici e profonde appaiono una porta magica. Sotto le viti è terra rossa dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là dalle foglie sta il cielo. È un cielo sempre tenero e maturo, dove non mancano – tesoro e vigna anch’esse – le nubi sode di settembre. Tutto ciò è familiare e remoto, infantile, a dirla breve, ma scuote ogni volta, quasi fosse un mondo. La visione s’accompagna al sospetto che queste non siano se non le quinte di una scena favolosa in attesa di un evento che né il ricordo né la fantasia conoscono. Qualcosa di inaudito è accaduto o accadrà su questo teatro. Basta pensare alle ore della notte, o del crepuscolo, in cui la vigna non cade sotto gli occhi e si sa che si distende sotto il cielo, sempre uguale e raccolta. Si direbbe che nessuno vi è mai camminato, eppure c’è chi la lavora a tralcio a tralcio e alla vendemmia è tutta gaia di voci e di passi. Ma poi se ne vanno, ed è come una stanza in cui da tempo non entra nessuno e la finestra è aperta al cielo. Il giorno e la notte vi regnano; a volte vi fa fresco e coperto – è la pioggia -, nulla muta nella stanza, e il tempo non passa. Neanche sulla vigna il tempo passa; la sua stagione è settembre e torna sempre, e appare eterna. Solamente un ragazzo la conosce davvero; sono passati gli anni, ma davanti alla vigna l’uomo adulto contemplandola ritrova il ragazzo. Il sospetto di ciò che deve – che è dovuto – accadere, la mantiene la stessa e risuscita nel ricordo l’infanzia. Ma nulla è veramente accaduto e il ragazzo non sapeva di attendere ciò che adesso sfugge anche al ricordo. E ciò che non accadde al principio non può accadere mai più.
Se non forse sia stata proprio questa immobilità a incantare la vigna. Un sentiero l’attraversa all’insù, dimezzando i filari e tagliando una porta sul cielo vicino. Il ragazzo saliva per questi sentieri, vi saliva e non pensava a ricordare; non sapeva che l’attimo sarebbe durato come un germe e che un’ansia di afferrarlo e conoscerlo a fondo l’avrebbe in avvenire dilatato oltre il tempo. Forse quest’attimo era fatto di nulla, ma stava proprio in questo il suo avvenire. Un semplice e profondo nulla, non ricordato perché non ne valeva la pena, disteso nei giorni e poi perduto, riaffiora davanti al sentiero, alla vigna, e poi si scopre infantile, di là dalle cose e dal tempo, com’era allora che il tempo per il ragazzo non esisteva. E allora qualcosa è davvero accaduto. È accaduto un istante fa, è l’istante stesso: l’uomo e il ragazzo s’incontrano e sanno e si dicono che il tempo è sfumato. L’uomo sa queste cose contemplando la vigna. E tutto l’accumulo, la lenta ricchezza di ricordi d’ogni sorta, non è nulla di fronte alla certezza di quest’estasi immemoriale. Ci sono cieli e piante, e stagioni e ritorni, ritrovamenti e dolcezze, ma questo è soltanto passato che la vita riplasma come giochi di nubi. La vigna è fatta anche di questo, un miele dell’anima, e qualcosa nel suo orizzonte apre plausibili vedute di nostalgia e speranza. Insoliti eventi vi possono accadere che la sola fantasia suscita, ma non l’evento che soggiace a tutti quanti e che tutti quanti abolisce: la scomparsa del tempo. Questo non accade, è: anzi è la vigna stessa.
Davanti al sentiero che sale all’orizzonte, l’uomo non ritorna ragazzo: è ragazzo: Per un attimo, in cui giunge a far tacere ogni ricordo, si trova entro gli occhi la vigna immobile, istintiva, immutabile, quale ha sempre saputo di avere nel cuore. E non accade nulla, perché nulla può accadere che sia più vasto di questa presenza. Non occorre nemmeno fermarsi davanti alla vigna e riconoscerne i tratti familiari e inauditi. Basta l’attimo dell’incontro e già il ragazzo e l’uomo adulto han cominciato il loro dialogo che, ricco di giorni, dall’inizio non muta.”

Per Pavese questa raccolta di prose e racconti non era un punto di arrivo, ma occupava un posto nella sua ricerca letteraria, infatti scrisse nel risvolto della prima edizione di Feria d’agosto:
“ Non sempre si scrivono romanzi. Si può costruire una realtà accostando e disponendo sforzi e scoperte che ci piacquero ognuno per sé, eppure siccome tendevano a liberare da una stessa ossessione, fanno avventura e risposta. Qui, come in tutte le avventure, si è trattato di fondere insieme due campi d’esperienza. E la risposta potrebbe essere questa: solamente l’uomo fatto sa essere ragazzo.”
Postumo nel 1961, venne pubblicato il libro “Racconti” con l’aggiunta di brevi narrazioni mai pubblicate da Pavese.




